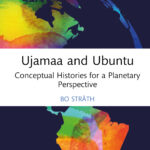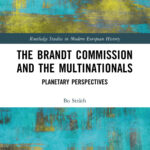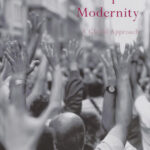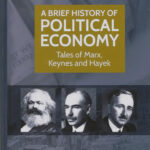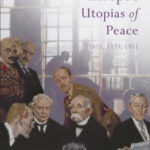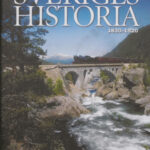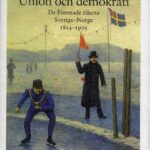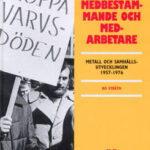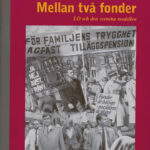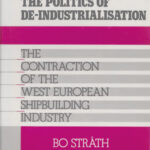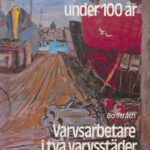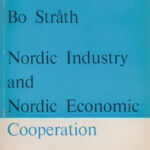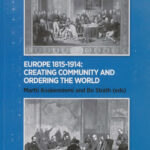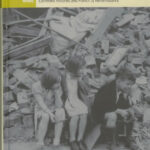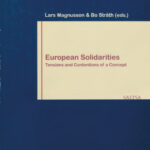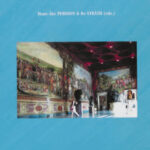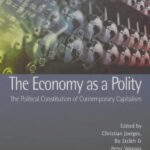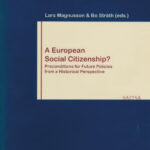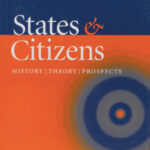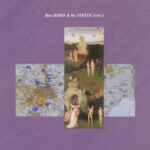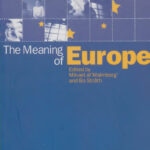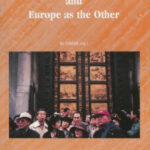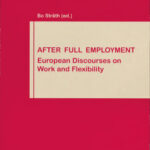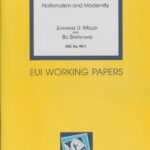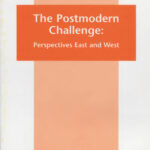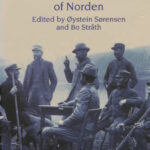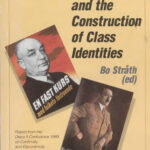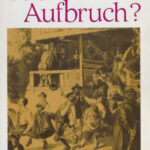Le relazioni transatlantiche: una breve storia dal 1945
Nel 1945 gli Stati Uniti emersero come potenza mondiale dominante. A differenza di quanto era accaduto dopo la prima guerra mondiale, il presidente e il Congresso giunsero alla conclusione che il Paese era una potenza mondiale e agirono di conseguenza. Ben presto l’Unione Sovietica emerse come sfidante di quella posizione e gli Stati Uniti raccolsero il guanto di sfida. In una situazione in cui gli imperi europei si erano autodistrutti, i due imperi rimasti si divisero l’Europa. Il Piano Marshall del 1947 aprì una nuova fase nelle relazioni transatlantiche, più intensa rispetto al passato e con una leadership americana molto più marcata, il tutto sullo sfondo della Guerra Fredda. L’alleanza militare della NATO, con la partecipazione della Germania Ovest a partire dal 1955, sottolineò l’importanza militare delle relazioni. La guerra di Corea del 1950-53 le rafforzò durante la crisi nucleare degli anni ’50.
Tuttavia, dopo le crisi del Congo, di Berlino e di Cuba del 1960-62, che in retrospettiva sembrano essere il culmine della minaccia nucleare, non furono mai armoniose per un periodo di tempo significativo. Charles de Gaulle diffidava apertamente del dollaro come valuta mondiale e degli Stati Uniti come potenza mondiale. La Francia lasciò la parte militare della NATO. L’abbandono del gold standard del dollaro nel 1971-73 ha ulteriormente compromesso le relazioni. L’euforia seguita alla caduta dell’Unione Sovietica ha cambiato le condizioni della cooperazione transatlantica. La prospettiva globale è passata in primo piano. Ciò non è cambiato in linea di principio quando l’11 settembre 2001 ha posto fine al sogno della fine della storia e di un mondo liberale unico, come immaginato da Francis Fukuyama (1992). Samuel Huntington (1996) aveva già respinto la visione del mondo di Fukuyama alcuni anni prima, quando descriveva il futuro come uno scontro di civiltà. L’attacco alle Torri Gemelle sembrava confermare la tesi di Huntington e ha portato a un’ondata moralistica neoconservatrice con una lotta per la democrazia e i valori occidentali in tutto il mondo. La guerra in Iraq del 2003 fu il culmine della campagna che creò una frattura nella cooperazione europea. Come è noto, fu una guerra giustificata con menzogne. Il segretario alla Difesa Donald Rumsfeld divise imperiosamente l’Europa tra la vecchia, che rifiutava di partecipare alla guerra, e la nuova, che si unì alla caccia a Hussein nella «coalizione dei volenterosi». Il libro di Robert Kagan Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order (2003), che parlava degli Stati Uniti come Marte e dell’Europa come Venere, dava espressione alle forti tensioni transatlantiche che si diffondevano all’interno dell’Europa. Formalmente, la NATO non era coinvolta. Tuttavia, durante questo periodo turbolento di tensioni transatlantiche, si verificò una distensione tra la Russia e l’Occidente che sembrò fondersi in un unico insieme. La nuova Russia era legata alla NATO attraverso il Partenariato per la Pace del 1994 e il Consiglio NATO-Russia del 2002. Durante il periodo di comprensione reciproca nelle relazioni con la Russia, la NATO è diventata sempre più una forza internazionale per un robusto intervento di polizia/militare nei conflitti locali a livello globale e sempre meno una forza di difesa contro le invasioni. Nel quadro della comprensione reciproca, la Polonia, la Repubblica Ceca e l’Ungheria sono diventate membri della NATO nel 1999. Gli Stati baltici, la Romania, la Bulgaria, la Slovacchia e la Slovenia seguirono nel 2004, lo stesso anno in cui la maggior parte dei paesi dell’Europa orientale entrarono a far parte dell’UE. Lo spirito di consenso che aveva accompagnato l’espansione della NATO fu però di breve durata. La Russia aveva un rapporto complicato con la Georgia sin dal crollo dell’Impero Sovietico. In Georgia era forte il movimento che voleva avvicinare il paese all’Occidente, all’UE e alla NATO. Con il presidente Saakashvili, chiaramente orientato all’Occidente, questo movimento ha acquisito un volto. Le ambizioni sempre più esplicite del presidente hanno avuto un impatto negativo sulle relazioni tra la NATO e la Russia, che si sono notevolmente deteriorate a partire dal 2006. Nel febbraio 2007, Putin ha tenuto un discorso molto seguito alla conferenza annuale sulla sicurezza a Monaco, in cui ha preso chiaramente le distanze dal nuovo ordine mondiale, che ha definito monopolistico. Era chiaro chi fosse il bersaglio delle sue accuse di ambizioni monopolistiche. Nel maggio 2007, gli Stati Uniti hanno avviato colloqui con i governi di Varsavia e Praga per l’installazione di missili in Polonia e di relative strutture radar nella Repubblica Ceca. I piani della Georgia di aderire alla NATO hanno portato alla guerra del 2008 in Georgia. Le proteste dell’Euromaidan in Ucraina dal novembre 2013 al febbraio 2014 sono state una protesta contro la decisione del governo filo-russo di non firmare un accordo di associazione con l’UE. Le proteste si sono concluse con la fuga del presidente e la risposta della Russia con l’infiltrazione militare nel Donbas e l’annessione della Crimea.
Le crescenti tensioni tra Russia e NATO per il potere nel Caucaso e in Ucraina hanno temporaneamente rafforzato le relazioni transatlantiche dopo il 2014. Ma con Donald Trump alla Casa Bianca dal 2017 al 2021, le tensioni sono nuovamente aumentate, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento della cooperazione militare, dove inizialmente gli Stati Uniti erano il sostenitore finanziario più chiaro. L’attacco della Russia all’Ucraina nel febbraio 2022 ha rafforzato lo spirito di cooperazione, ma con il ritorno al potere di Trump nel gennaio 2025, la divisione atlantica è diventata più profonda che mai, mentre Trump si è avvicinato alla Russia.
L’ordine occidentale post-1945 incentrato sugli Stati Uniti è morto. Dal 1949, la pietra angolare di tale ordine è stata la NATO, che è più centrale delle istituzioni di Bretton Woods, del FMI e della Banca mondiale. L’essenza della NATO è l’articolo 5 sull’assistenza reciproca. In caso di emergenza, questo articolo non può essere messo alla prova dal punto di vista giuridico, ma è morale e si basa sulla fiducia reciproca. Trump ha minato tale fiducia facendo dell’articolo una questione di valutazione da parte del regime Trump del fatto che i membri europei abbiano pagato abbastanza per la loro autodifesa. È chiaro dal 2014, e sottolineato con enfasi dal febbraio 2022, che la minaccia della NATO è la Russia. Lo si afferma senza entrare nella questione molto dibattuta se la NATO, dal punto di vista della Russia dopo il 1990, fosse una minaccia per la Russia, ma con l’osservazione che il dibattito non fornisce in ogni caso una base per l’attacco della Russia all’Ucraina. Dopo la guerra di aggressione su vasta scala del febbraio 2022, la NATO è stata sempre più riattivata nel pensiero strategico e nella pianificazione come difesa contro l’invasione, ruolo che ha avuto all’inizio. Il riavvicinamento di Trump alla Russia alle spalle dell’Europa ha sottolineato, ancora più della controversia finanziaria sull’entità delle spese per la difesa, la disintegrazione di ciò che veniva chiamato Occidente. La NATO continua formalmente, ma gli Stati Uniti non condividano la valutazione della minaccia del Europa.
La situazione nella primavera del 2025
Dalla seconda inaugurazione di Trump, una profusione di commenti ha commentato la disintegrazione dell’ordine mondiale e ha cercato spiegazioni dentro e fuori Trump stesso, sia a lungo che a breve termine. L’obiettivo qui non è quello di riassumere il dibattito, ma di identificare alcune linee di argomentazione come base per una discussione su ciò che sta accadendo e perché. È una ironia della storia che la comunità che ruota attorno al concetto di Occidente, creato da un presidente americano quasi 80 anni fa, sia ora lacerata da un altro presidente americano. Un ordine mondiale transatlantico che ha quasi ottant’anni – non di più, ma nemmeno di meno – una storia che va da Truman a Trump, viene distrutta, deliberatamente, momentaneamente e con un martello. Governando con decreti presidenziali e dichiarazioni pubbliche, spesso brevi e drastiche sui social media, Trump sta plasmando l’opinione pubblica e creando fatti che aggirano il Congresso e sfidano provocatoriamente le decisioni dei tribunali. La politica sta accelerando e semplificando contesti complessi. Suscita forti emozioni e diventa polemica. Si tratta di riconquistare la grandezza perduta dell’America (MAGA, Make America Great Again). La Cina e l’Europa/l’UE sono dipinte come le cause principali. Mentre la Cina è trattata con un certo rispetto retorico, le critiche all’Europa sono più sfrenate. Il discorso di apertura del vicepresidente J D Vance alla conferenza annuale sulla sicurezza di Monaco del 14 febbraio 2025 (Casa Bianca, 14-02-2025) ha suscitato stupore, shock e rabbia in Europa. Con uno stile conflittuale, Vance ha affermato che l’Europa non è sufficientemente democratica. Due cose in particolare distinguono l’Europa dagli Stati Uniti come modello da seguire, e ha chiesto miglioramenti in questi ambiti. L’Europa tratta male i partiti populisti di destra. Questi devono essere chiaramente e inequivocabilmente coinvolti nella politica parlamentare. Il secondo punto riguardava le restrizioni alla libertà delle piattaforme digitali. Queste restrizioni sono espressione di carenze antidemocratiche nella libertà di espressione che devono essere corrette. Le ripetute rivendicazioni territoriali di Trump sulla Groenlandia, il Canada e il Canale di Panama, con minacce di annessione, sono state una sfida aperta al diritto internazionale che ha rafforzato l’impressione di una rottura desiderata con l’ordine mondiale in vigore dal 1945. In due casi, le rivendicazioni erano dirette contro paesi membri della NATO sin dalla sua fondazione nel 1949.
In un discorso del 7 aprile 2025, il consigliere economico di Trump, Stephen Miran, ha chiarito il senso della lotta per il MAGA. Gli Stati Uniti forniscono due beni pubblici globali: un ombrello di sicurezza controllato dall’esercito statunitense e il dollaro, con i titoli di Stato statunitensi al centro, attorno al quale ruota il sistema finanziario internazionale. Entrambi sono costosi per gli Stati Uniti e il presidente ha voluto chiarire che gli Stati Uniti non sono più disposti a pagare per il free ride di altre nazioni (dichiarazione della Casa Bianca, 7 aprile 2025). L’aspetto della politica di sicurezza è stato espresso nell’affermazione che i membri europei della NATO non stanno pagando la loro giusta quota dei costi di difesa, che secondo Trump è pari al 5% del PIL. A volte si esprime come se ciò si riferisse ai contributi dei membri della NATO al bilancio dell’Alleanza, mentre in realtà la cifra si riferisce alla loro spesa per la difesa in percentuale del PIL, dove il consenso è stato del 2%. Ha chiarito che i membri che non pagano abbastanza non possono aspettarsi un sostegno attivo da parte degli Stati Uniti in caso di guerra. Con il suo ostentato riavvicinamento alla Russia sotto le spoglie di mediatore autoproclamato (nella guerra in Ucraina), Trump ha minato la fiducia nell’alleanza ancora più dei dubbi che ha seminato sull’articolo 5. Trump ha fatto vacillare l’intera alleanza. Il divario in materia di politica di sicurezza è aggravato dal divario in materia di politica commerciale che Trump sta creando con dazi grotteschi. Le regole non valgono più. La politica internazionale basata sulle regole del diritto internazionale e del diritto commerciale sta cedendo il passo all’arbitrarietà della politica di potere. I nuovi dazi sono una rottura dimostrativa con l’ordine mondiale neoliberista costruito dagli anni ’80 intorno alle idee del libero commercio mondiale con produzione dove è più economico nelle catene di approvvigionamento globali, dove la precisione temporale sostituisce i costosi magazzini e dove i salari e gli standard sociali sono spinti al ribasso.
Il protezionismo sta tornando come programma per la prima volta dagli anni ’30 e le argomentazioni dell’amministrazione Trump ricordano il mercantilismo. Nel suo discorso del 7 aprile, il consigliere del presidente Trump, Miran, è stato chiaro sullo scopo dei dazi: costringere gli altri paesi a pagare un tributo per mantenere l’impero americano. Gli impegni finanziari costringono gli Stati Uniti a tassare ingiustamente i lavoratori americani, un’affermazione che suggerisce l’idea che le entrate derivanti dai dazi creino margini per tagli fiscali. Ma l’idea è anche quella di costringere le aziende industriali a trasferire la produzione negli Stati Uniti. Il dollaro come valuta standard mondiale ha portato a distorsioni dei tassi di cambio, che a loro volta hanno creato barriere commerciali ingiuste e, a lungo termine, surplus commerciali insostenibili nei confronti degli Stati Uniti. L’argomento vale per il commercio di beni, mentre vengono ignorati i grandi surplus commerciali statunitensi nel commercio di servizi creati dai giganti della tecnologia digitale.
Entrambe le aree problematiche, la sicurezza e la politica commerciale, sono polarizzate da un’immagine spudorata dell’Europa dipinta dal regime di Trump, in cui gli europei sono scrocconi e parassiti degli Stati Uniti. Sono dei free rider. La Cina è oggetto della stessa caricatura, ma le emozioni sembrano più forti quando si tratta dell’Europa. L’integrazione europea, culminata nell’UE, è stata creata per danneggiare gli Stati Uniti. Il presidente non fornisce alcuna prova a sostegno di questa tesi. Nella NATO, gli europei non fanno la loro parte dal punto di vista finanziario e nel commercio sfruttano ingiustamente gli Stati Uniti. L’Europa appare non solo come una caricatura, ma anche come un nemico dichiarato.
La conclusione è chiara: l’Occidente così come è emerso dopo il 1945 non esiste più. Il regime di Trump sta sviluppando un’immagine nemica in cui la causa di tutti i mali risiede in Europa. In un saggio, Fintan O’Toole sviluppa le sue riflessioni sull’eurofobia di Trump (O’Toole 2025). Sebbene la percezione della realtà di Trump sia instabile e in continua evoluzione, egli ha idee fisse e istinti immutabili. Sono proprio queste ossessioni e questi istinti che stanno ora ridefinendo le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Europa in modo più drammatico che in qualsiasi altro momento dal 1945. Trump non sta abbandonando l’Europa, la sta calpestando. Il suo regime non ha perso interesse per l’Europa. Ha sviluppato un interesse malizioso nel distruggere l’UE, scrive O’Toole. L’ostilità di Trump nei confronti dell’UE si è manifestata per la prima volta nel suo entusiastico sostegno alla Brexit. Durante il suo primo mandato presidenziale, la sua convinzione che l’UE sia un “nemico” alla pari della Cina è emersa di tanto in tanto, ma per la maggior parte è rimasta latente. Ora, l’interesse non è più quello di abbandonare l’Europa al suo destino, ma di minare e rimodellare l’UE dall’interno attraverso il sostegno aperto ai partiti populisti di destra ed estremisti, come espresso da Musk, Vance, Rubio e altri. Non è solo che l’UE non può più dare per scontata la benevolenza degli Stati Uniti, ma deve presumere che possa svilupparsi un’ostilità attiva in concerto o in collaborazione con la Russia.
Il grande problema è che il regime di Trump non solo sta intervenendo in specifici settori politici, ma sta attaccando il sistema stesso delle norme che regolano concetti come l’integrità territoriale e la sovranità nazionale. Trump sta seguendo Putin. Ciò ha conseguenze tangibili, soprattutto nelle relazioni internazionali, dove non esiste un Leviatano, un potere protettivo che difende le norme e le regole attraverso la forza di polizia e militare. Trump attacca la norma della libertà di ricerca e impartisce istruzioni dettagliate alle università minacciate. Mostra disprezzo per la conoscenza scientifica.
Il linguaggio che ha avuto inizio con le fake news e la falsa verità o verità alternativa durante il primo mandato sta accelerando il suo allontanamento da quella che un tempo era considerata la base della ragione. La ricerca scientifica della conoscenza oggettiva, unita alla consapevolezza che l’oggettività può essere vista da più prospettive e che i pregiudizi ideologici possono offuscare la ricerca, viene minata e si assiste a una rinascita della caccia alle streghe. La ragione critica di Kant come principio accademico di azione viene rifiutata. L’intenzione è forse quella di creare una base per sostituire le idee del filosofo con l’intelligenza artificiale prodotta dai giganti della tecnologia.
Il linguaggio si radicalizza non solo in senso orwelliano, dove la guerra è chiamata pace e la pace è chiamata guerra, ma anche diventando più polarizzato ed emotivo. L’immigrazione è chiamata invasione. L’emigrazione diventa rimigrazione e deportazione. Va notato che questo sviluppo linguistico è lo stesso in Europa, dove la questione dell’immigrazione su entrambe le sponde dell’Atlantico sta diventando un catalizzatore, una questione surrogata per una serie di altri problemi sociali, che possono essere riassunti brevemente in due: i problemi socio-economici causati dalle devastazioni del neoliberismo e dal suo crollo nella bolla speculativa del 2008, e il cambiamento climatico. Il linguaggio sta diventando più eccessivo. Ci manca un linguaggio che descriva il nuovo mondo come la differenza che è rispetto alla democrazia che era lo standard. I suoi concetti utilizzano lo standard democratico, ma non sono adeguati (Stråth & Trüper 2025). L’Europa si aggrappa agli ideali in cui credeva e continua a utilizzare le espressioni che hanno plasmato tali ideali invece di descrivere il cambiamento. L’Europa vuole credere di essere ancora nel periodo di massimo splendore della democrazia, quando era data per scontata per sempre. L’Europa si vede in contrasto con il fanatismo e il culto della leadership che governa gli Stati Uniti, guidati da potenti interessi in alleanza con gli algoritmi. È fondamentale per l’Europa riconoscere i rischi per la democrazia che la rivoluzione digitale ha portato con sé anche in Europa e creare un linguaggio che descriva tali rischi. Che tipo di sfera pubblica costituiscono i social media rispetto alle sfere pubbliche che hanno sostenuto le democrazie negli anni ’50 e ’60? La distinzione tra pubblico e privato, che Thomas Hobbes propose ai governanti quasi 400 anni fa come mezzo per porre fine a decenni di guerre di religione in Europa, si sta disintegrando man mano che il privato diventa pubblico nei social media. Questa rinuncia volontaria alla privacy cambia le condizioni della critica sociale e del controllo governativo. Le emozioni che ribollono e le semplificazioni che distruggono valori complessi stanno infantilizzando e brutalizzando il dibattito pubblico. È fondamentale per l’Europa assumere il controllo degli algoritmi e regolamentarli per salvare la democrazia. E in fretta.
Sebbene il conflitto tra Stati Uniti ed Europa sia il problema principale, è importante ricordare che l’Europa è pericolosamente vicina agli Stati Uniti nello sviluppo che sta causando così tanti sconvolgimenti, ovvero l’emotività e l’infantilizzazione del dibattito pubblico. Non bisogna sopravvalutare le differenze tra gli Stati Uniti e l’Europa in termini di intensità dei social media. Si potrebbe parlare di un punto di svolta europeo in cui tutto sta andando nella direzione americana. L’Europa vorrebbe essere, ma non è un baluardo di valori. Dobbiamo partire da questa consapevolezza.
Un ordine mondiale in dissoluzione. E adesso?
I segni di un cambiamento negli Stati Uniti sono emersi già durante la guerra in Iraq, e l’inversione di tendenza si è verificata con l’elezione di Trump alla presidenza nel 2016, che i leader europei non volevano vedere e speravano invece che il suo mandato fosse temporaneo e che fosse aperto al dialogo durante il suo mandato. Nel 2020, con l’elezione di Biden, hanno visto Trump come una nota a piè di pagina della storia. Oggi sappiamo che Biden è stato una parentesi. Nel dibattito europeo in vista delle elezioni presidenziali dell’autunno 2024, tutti professavano di prepararsi al ritorno di Trump, ma la preparazione consisteva più che altro nel convincersi, senza un’analisi approfondita, che Trump sarebbe stato lo stesso dell’ultima volta e che la soluzione stava nel trovare un accordo adulandolo. Durante l’autunno, i preparativi per Trump si sono spostati maggiormente verso le speranze riposte in Harris. Nessuno dei pianificatori aveva immaginato il Trump che è tornato, tanto meno le sue azioni sulla questione ucraina. Tutti sono stati colti di sorpresa dalla sua determinazione, sostenuta dagli oligarchi della tecnologia, con o senza motoseghe.
Con autorevolezza intellettuale, Jürgen Habermas ha descritto la rottura in termini forti in un articolo di giornale del marzo 2025 (Habermas 2025). Egli parla di una rottura epocale che ha profonde conseguenze per l’Europa. Se l’UE non riuscirà a trovare una risposta convincente, l’Europa sarà trascinata nel vortice causato dal naufragio della superpotenza, sostiene. Perché si tratta effettivamente di una potenza in declino, non in ascesa. Habermas condanna l’incapacità o lo scarso interesse dei leader europei, la loro incomprensibile miopia nel considerare gli Stati Uniti come una potenza leader. La fiducia incrollabile del cancelliere tedesco Scholz nell’unità dell’Occidente sotto la guida degli Stati Uniti di Biden in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha portato gli altri leader europei nella direzione sbagliata, invece di spingere l’Europa ad assumersi la responsabilità in Ucraina per difendere la propria sicurezza e i valori europei. Questo fallimento si è rivelato disastroso quando Trump ha iniziato a negoziare con Putin scavalcando l’UE, che è stata costretta a stare a guardare, sostiene Habermas. Con Trump 2, la questione del destino dell’Ucraina è diventata una questione di autodifesa esistenziale dell’UE in una situazione in cui non può contare sulla protezione degli Stati Uniti.
Scholz ha certamente una parte di responsabilità per la fissazione dell’Europa sugli Stati Uniti dopo l’invasione russa dell’Ucraina, forse più di chiunque altro. A sua discolpa, però, si può dire che i legami della Germania con l’Occidente erano saldamente radicati fin dai tempi di Adenauer e si erano rafforzati ulteriormente dopo la brutale fine, nel febbraio 2022, delle strette relazioni con la Russia all’insegna del motto Wandel durch Handel (cambiamento attraverso il commercio). Si trattava di legami che Willy Brandt aveva forgiato all’inizio degli anni ’70 in una situazione storica completamente diversa, all’insegna del motto Wandel durch Annäherung (cambiamento attraverso il riavvicinamento). Quando dopo il 1990 quel motto assunse una formulazione neoliberista, nacque l’idea fatale che fosse il mercato a guidare automaticamente l’assetto. In qualità di ministro delle finanze nella grande coalizione con Angela Merkel, Scholz perse il contatto con le idee di Brandt, ma non era affatto il solo. In Germania, la fiducia negli Stati Uniti era incrollabile come lo era in Russia prima del febbraio 2022, dopo che la gente aveva potuto liquidare Trump 1 con un sospiro di sollievo come una parentesi. Infine, le richieste di adesione alla NATO da parte della Finlandia e della Svezia dopo l’attacco russo all’Ucraina dimostrano che la Germania di Scholz non era sola nella sua fiducia negli Stati Uniti.
Se Scholz è ora il candidato più ovvio per essere descritto come il Chamberlain del nostro tempo, la domanda è: chi è Churchill? Qui non si può pensare ad altri che al presidente ucraino Zelensky. Senza entrare nei dettagli delle somiglianze, si può individuare una differenza decisiva. Churchill aveva il sostegno degli Stati Uniti e, dopo l’estate del 1941, anche dell’Unione Sovietica. Più la guerra va avanti, più Zelensky sembra rimanere solo. L’impotenza dell’Europa cresce mentre Trump e Putin negoziano sull’Ucraina. L’Europa si trova ad affrontare il compito di assumere il ruolo degli Stati Uniti nel sostegno all’Ucraina, ma sembra che non ci sia posto per l’Europa nella dinamica che si sta delineando. Le difficoltà sono grandi, ma il rifiuto di riconoscerlo e di trarne le conseguenze le rende ancora maggiori.
L’imprevedibilità è totale sullo sfondo di ciò che Habermas descrive come il «comportamento bizzarro e il discorso confuso» di Trump alla cerimonia di insediamento nel gennaio 2025, con «la fantastica evocazione di un’età dell’oro ormai alle porte». L’affettazione narcisistica di Trump ha dato allo spettatore televisivo impreparato che ha assistito alla cerimonia l’impressione di una «dimostrazione clinica di un caso psicopatologico», ma gli applausi fragorosi nella sala e «l’accordo aspettato di Musk e delle altre luminari della Silicon Valley» non hanno lasciato dubbi sulla determinazione della cerchia ristretta di Trump. La roadmap porta la firma della Heritage Foundation ed è nota da tempo (Heritage Foundation 2024). Si tratta di una ristrutturazione istituzionale dello Stato. Gli esempi europei sulla stessa linea, che coinvolgono figure come Orbán e il regime di Kaczynski, si limitano a restrizioni statali al sistema giuridico e ai media. La riforma negli Stati Uniti è molto più radicale. Il commissario epuratore Musk, armato di motosega, ha obiettivi più ambiziosi del semplice taglio dell’amministrazione pubblica. L’obiettivo a lungo termine è sostituire l’apparato statale e le sue regole con una tecnocrazia controllata digitalmente, sostiene Habermas. La politica nel quadro dello Stato storico deve essere sostituita da una gestione aziendale controllata digitalmente da un’amministrazione statale fortemente ridimensionata (Habermas 2025). I piani dei tecnocrati per trasformare il governo in un consiglio di amministrazione aziendale, se realizzati, avrebbero conseguenze difficili da prevedere.
Per Habermas non è del tutto chiaro come queste idee espansionistiche possano conciliarsi con lo stile di azione di Trump, una “politica di decisioni sorprendentemente arbitrarie, libere dalle norme vigenti”. L’oscena fantasia del negoziatore e agente immobiliare di ricostruire la Striscia di Gaza, ormai deserta, suggerisce l’irrazionalità di una persona deliberatamente imprevedibile che potrebbe scontrarsi con i piani a lungo termine del vicepresidente, ispirati dalla religione, per una definizione populista di destra o autocratica della democrazia, dove la completa libertà digitale per i giganti della tecnologia è il principio guida. Habermas osserva che il tipo autoritario di digitalizzazione ha poco a che vedere con il fascismo storico. Una volta distrutte, le istituzioni non possono essere facilmente ricreate. Alla conclusione di Habermas si può aggiungere che i paladini, gli adulatori e i giullari che compongono l’entourage immediato del presidente americano non sono affatto una novità. La storia ne offre molti esempi. La novità è il loro potere tecnologico, che solleva interrogativi su chi detiene realmente il controllo.
L’imprevedibilità come strumento politico di potere non significa che Trump non abbia un piano o un obiettivo. Si deve presumere che sia serio e che abbia un piano per rendere l’America di nuovo grande e forte, anche se sorprendentemente si discute poco su come potrebbe essere tale piano. È difficile discernere una visione a lungo termine in un approccio discontinuo in cui gli obiettivi vengono specificati e la chiamata all’attacco viene lanciata con la stessa rapidità con cui viene lanciata la chiamata alla ritirata: pace in Ucraina, dazi per proteggere gli Stati Uniti dallo sfruttamento straniero, ecc. Chiede di attaccare e promette grandi cose e svolte decisive, ma quando incontra una forte resistenza, l’attacco si ferma e nuove energie vengono investite in un nuovo obiettivo, e così via. Il passaggio dalla “mediazione di pace” in Ucraina alla campagna tariffaria senza restrizioni, per poi tornare all’Ucraina, segue uno schema ben preciso.
Trump vuole distruggere le istituzioni, le regole e i modelli di cooperazione dell’ordine mondiale esistente. Vuole creare un (dis)ordine in cui governano i forti. I piccoli Stati non contano. Una manciata di superpotenze decidono il destino del mondo tra di loro. I loro accordi sono spesso non scritti, segreti e/o impliciti e non necessariamente duraturi.
È un mito che l’imperialismo sia scomparso con la decolonizzazione dopo il 1945. Durante la Guerra Fredda, è continuato nel Terzo Mondo sotto forma di guerre per procura tra superpotenze e competizione con armi convenzionali (Westad 2005; Stråth & Trüper 2025). Ma, sorprendentemente, è diventato forte come lo è oggi.
Se si guarda un mappamondo dall’alto e si segue la massa continentale canadese dal Canale di Labrador verso ovest, si arriva in Alaska e poi attraverso lo Stretto di Bering fino alla Siberia e infine a Murmansk. Da lì, è solo un passo alla Groenlandia. Guardando nella direzione opposta, verso est dal Labrador, si raggiunge rapidamente la Groenlandia e da lì si può arrivare a Murmansk dall’altra parte. Se la Groenlandia e il Canada appartenessero agli Stati Uniti, questi ultimi e la Russia abbracerebbero il globo sotto il Polo Nord e controllerebbero sia il Passaggio a Nord-Ovest che quello a Nord-Est. Avrebbero inoltre il controllo di quantità sconosciute di minerali rari. Va sottolineato che si tratta di un ragionamento ipotetico e che, se si rivelasse vero, una cosa sarebbe ciò che Trump vuole e un’altra ciò che riuscirebbe a ottenere. Ma bisogna presumere che Trump abbia un piano e una visione del mondo. È improbabile che la Russia di Putin cada come un frutto maturo davanti agli inviti di Trump, che deve anche tenere conto delle sue relazioni con la Cina. Le relazioni imperialistiche tra le superpotenze non sono necessariamente armoniose. Sono guidate dal potere e opportunistiche, mutevoli piuttosto che amicizie durature.
Sullo sfondo di questo ragionamento ipotetico ma non irrealistico, colpisce quanto l’Europa appaia isolata e insignificante nel gioco della pace in Ucraina e nel riavvicinamento tra Stati Uniti e Russia. Si può solo concludere che se pace significa che Putin può mantenere ciò che la Russia ha conquistato e Trump costringe un’Ucraina lacerata e stanca della guerra ad accettare l’estrazione americana di minerali in ciò che resta dell’Ucraina, allora sì, gli scavi e le trivellazioni americane garantiranno l’integrità del resto dell’Ucraina dall’aggressione russa. A quale prezzo, ci si potrebbe chiedere, ma non saranno necessarie truppe europee di pace.
In un breve articolo, Nils Gilman vede emergere una coalizione petrolifera e del gas contro le energie rinnovabili tra gli Stati Uniti e la Russia sulla base del continuo inquinamento atmosferico (Gilman 2025). In questo contesto, vale la pena notare l’interesse dichiarato sia della Russia che degli Stati Uniti per il Medio Oriente. Una tale coalizione che controlla l’Artico con i passaggi a nord-ovest e nord-est difficilmente potrebbe evitare uno scontro con la Cina, che più di qualsiasi altra potenza si è profilata come paladina dell’energia verde. Gli Stati Uniti e la Russia non possono escludere la Cina, e non lo fanno, ma stanno cercando un accordo con quello che un tempo era chiamato il Regno di Mezzo e che ora sembra voler rivendicare questo nome. Al posto di un triumvirato potrebbe emergere un dramma triangolare. Dove si colloca l’UE in una situazione del genere? E l’India? L’idea, se esiste, è quella di placare Trump, o l’UE dovrebbe sperare che tutto si risolva? Come il topo che fissa scioccato il serpente, cercando eufemisticamente di nascondere la sua paralisi con l’affermazione di mantenere la calma.
Come è potuto accadere? Due interpretazioni americane
Una valanga di pubblicazioni cerca di comprendere e interpretare gli sviluppi negli Stati Uniti. Ne segnaleremo due, che non intendono certo esaurire le possibili interpretazioni.
Robert Kagan, che ha paragonato gli Stati Uniti a Marte e l’Europa a Venere (Kagan 2003), ha abbandonato le sue convinzioni neoconservatrici dell’era della guerra in Iraq e riflette in un nuovo libro su come gli sviluppi americani avrebbero potuto prendere la piega che hanno preso (Kagan 2024). Il suo punto di partenza è che la Costituzione degli Stati Uniti del 1787 era viziata fin dall’inizio. Essa proclamava l’uguaglianza e i diritti di tutte le persone, ma i suoi autori erano consapevoli che gli schiavi neri non erano inclusi. Sia Washington che Jefferson possedevano schiavi. I Padri Fondatori si consolavano con la speranza che, ad un certo punto dello sviluppo del popolo americano, la ragione avrebbe prevalso e si sarebbe raggiunto un accordo sull’abolizione della schiavitù. Negli anni ’30 dell’Ottocento sorsero tensioni quando nuovi Stati dovevano essere ammessi nell’Unione e bisognava determinare il loro status sulla questione della schiavitù. Queste tensioni scatenarono la guerra civile nel 1861-65. Il conflitto non riguardava solo la schiavitù, ma anche le divisioni tra città e campagna e i diversi livelli di industrializzazione, con forze illiberali che sfidavano continuamente la costituzione liberale.
Dopo la guerra civile, l’immigrazione e l’industrializzazione si intensificarono e sorsero nuove tensioni tra i nuovi gruppi etnici: anglosassoni/nord europei contro sud europei contro est europei contro cinesi contro giapponesi. Il Chinese Exclusion Act del 1882 e l’Immigration Act del 1924 espressero queste tensioni. Il melting pot era tutt’altro che armonioso. Il dibattito razziale si intensificò. Gli anni ’20 furono l’era del jazz, ma anche del Ku Klux Klan, e le tendenze illiberali furono evidenti durante la crisi degli anni ’30. Le correnti universaliste, cosmopolite, internazionaliste, progressiste e liberali illuminate erano sempre presenti, ma erano costantemente messe in discussione, anche se gli anni ’30 e ’50 furono decenni fondamentalmente liberali. Ma c’erano anche il Ku Klux Klan, McCarthy e la questione razziale con il busing, Little Rock e Martin Luther King. E John F. Kennedy, che inviò la Guardia Nazionale per fermare la discriminazione razziale nelle università. Era come se la società americana non si fosse mai stabilizzata, ma fosse costantemente messa alla prova. L’11 settembre si inserisce bene in questo modello di instabilità. Come già accennato, Huntington aveva già scritto nel 1996 (Huntington 1996) del confronto tra civiltà come sfida del futuro. Ciò riguardava principalmente le civiltà cristiana e musulmana, che nel 2001 sarebbero giunte al culmine sotto forma di fanatismo religioso, terrorismo e guerra. Ma Huntington espresse anche preoccupazioni sulla composizione della popolazione americana. Nel 1965, i bianchi di origine europea costituivano l’84% della popolazione statunitense. Gli ispanici rappresentavano meno del 4% e gli asiatici meno dell’1%. All’inizio degli anni 2000, la percentuale di bianchi di origine europea era scesa al 62%, con una tendenza al ribasso, mentre gli ispanici rappresentavano il 18% e gli asiatici il 6%, con una tendenza al rialzo. Huntington (2004) espresse preoccupazione per la cultura anglo-protestante che trovava la sua espressione politica nella Costituzione del 1787.
È importante ricordare che il movimento liberale dell’Illuminismo è sempre stato presente. George W. Bush era un autentico multiculturalista e cosmopolita. Ma era costantemente sfidato da fondamentalisti antiliberali, fanatici religiosi e guerrieri culturali. Sotto aspetti importanti, il conflitto di distribuzione sociale è stato oscurato dal dibattito culturale, e questa oscurità è diventata un problema che Trump ha saputo canalizzare con successo. Secondo Kagan, la lunga tradizione antiliberale si esprime nel movimento di Trump. Kagan vede Trump come parte di una lunga tradizione antiliberale americana. Kagan non esita a paragonare direttamente Trump a Hitler come tipo di leader carismatico, che gioca sulle emozioni e incita alla paura, al terrore e all’ansia. Trump crea obbedienza attraverso la paura piuttosto che lealtà attraverso la fiducia. La questione che Kagan non approfondisce è se possiamo continuare a contare su un ritorno della altrettanto lunga continuità liberale che ha caratterizzato il Paese sin dalla sua fondazione, con entrambe le continuità in costante contrapposizione.
I politologi Stephen Hanson e Jeffrey Kopstein hanno una prospettiva internazionale più ampia sugli sviluppi americani. Essi vedono un modello emerso negli ultimi decenni, che collegano a ciò che Max Weber chiamava paternalismo, una sottocategoria del governo tradizionale nella sua tipologia di governo (Hansson & Kopstein 2024, Weber 1980 [1922]: 122-176). Il governo arbitrario di leader che si autoproclamano padri della nazione, promettendo grandezza e sicurezza in un periodo percepito come incerto e in declino. Si circondano di una corte di familiari, favoriti ed esperti di odio nelle amministrazioni governative e nelle organizzazioni internazionali. I governanti e i loro stretti collaboratori non esitano ad arricchirsi a spese della popolazione. La corruzione è una parte importante del sistema, un lubrificante. Esempi storici citati da Hanson e Kopstein sono gli zar russi. Quando necessario, ricorrevano a misure coercitive e mobilitavano il sostegno delle élite economiche e degli intellettuali. Ciò che hanno in comune è la violazione dello Stato di diritto e dei principi giuridici e l’introduzione dell’arbitrarietà nel sistema. Concetti come autocrazie, dittature, autoritarismi e populismi descrivono il fenomeno, ma non ne coprono la totalità e la complessità. In Europa, il pensiero va a Putin e Orbán, e negli Stati Uniti, ovviamente, a Trump. Ma ci sono molti altri nomi, come Johnson, Bolsonaro, Erdogan, Milei e Modi, tutti diversi tra loro con i propri profili. Il fenomeno è globale. Trump non è quindi unico, ma segue un modello emergente, anche se sembra essere il più ostentato e quello che cerca più di tutti i riflettori nella sua cerchia.
Questo sviluppo è un attacco globale su vasta scala allo Stato moderno basato sulle regole, al declino della democrazia e alla transizione verso il governo personale. Hansson e Kopsstein vedono Putin come forse l’anello più importante di questa trasformazione e non esitano a indicarlo come fonte di ispirazione di Trump. Allo stesso tempo, sottolineano che il successo di Putin come guida è dovuto al fatto che il terreno era stato ben preparato. L’ideologia neoliberista ha trasformato molti liberali sociali in libertari. Ha descritto l’apparato statale come una camicia di forza soffocante, che dovrebbe tenere le mani lontane dall’economia, tranne che per il compito di garantire la libertà di mercato. Il messaggio era potente e ha avuto successo. Hansson e Kopstein indicano il crollo dei mercati finanziari nel 2008 come fattore scatenante dello sviluppo paternalistico, ma nel caso russo c’è stato un preludio: le orde di consulenti occidentali che hanno invaso l’impero sovietico in disgregazione e hanno detto ai curatori fallimentari cosa dovevano fare. La proprietà statale fossilizzata doveva essere privatizzata, il che avrebbe rivitalizzato l’intera economia. La democrazia avrebbe richiesto tempo, ma sarebbe seguita automaticamente a un’economia in forte espansione. La svendita interna del patrimonio fallimentare, avviata e incoraggiata dall’Occidente, alimentò l’amarezza di Putin, che vide sempre più il crollo dell’impero sovietico come una catastrofe storica. Alla fine, il suo obiettivo divenne quello di cercare di ricrearlo. Non fu la NATO come minaccia esterna, ma la disintegrazione interna di quello che era stato promesso come un panorama fiorente che spinse Putin ad agire e ad abbandonare la fragile democrazia che cercava di sostituire la dittatura. Gli anni 2006-2008 hanno visto un cambiamento di rotta, con le ambizioni occidentali della Georgia – dove Putin vedeva naturalmente la NATO come una minaccia – e il discorso di Monaco come pietre miliari, e il crollo dei mercati finanziari nel 2008 come conferma di quanto fosse decadente e marcio l’Occidente capitalista e di quanto fosse giusta la svolta.
Il fondo oscuro del palcoscenico, l’attore e i produttori del dramma
In Cue the Sun! – The Invention of Reality TV, Emily Nussbaum (2024) descrive come l’attore Donald Trump abbia interpretato se stesso in una serie televisiva come una versione più ricca e di successo dell’agente immobiliare semi-fallito di cui le banche avevano iniziato a dubitare. Si è messo in scena come il magnate super ricco che milioni di americani che seguivano la serie hanno poi creduto che fosse. Ha interpretato una versione caricaturale di se stesso e il pubblico ha scambiato la caricatura per realtà. Anche l’attore ha scambiato la caricatura per il suo vero io. Ha funzionato così bene, scrive Nussbaum, perché Trump ha padroneggiato una caratteristica in particolare: l’arte di creare colpi di scena inaspettati. A questo proposito, Trump si comportava spesso in modo così impulsivo e si discostava dal copione a tal punto da far disperare i redattori responsabili. Dovevano rimontare gli episodi o addirittura fornire interi dialoghi con una voce fuori campo modificata a posteriori. Ma per quanto frustrati fossero i produttori, notavano anche che gli impulsi irregolari di Trump, i suoi colpi di scena improvvisi e i suoi capricci sorprendenti tenevano il pubblico con il fiato sospeso all’insegna del motto: nel mondo di Trump succede sempre qualcosa. È così che bisogna immaginare anche il vero presidente Trump quando interpreta il presidente Trump.
In realtà, anche i suoi sceneggiatori e redattori sono dietro le quinte, pronti a correggere ogni deviazione dal copione. Sarebbe un grave errore ignorare la sua cerchia di consiglieri e loro chi scrivano il copione e producono il dramma. Trump non è certo un burattino, ma non ha scritto lui stesso il copione.
Tra i produttori c’è il vicepresidente, il profondamente devoto J. D. Vance, convertitosi al cattolicesimo nel 2019 e che appare più sicuro e indipendente di qualsiasi altro vicepresidente prima di lui. E più ideologico. Il cattolicesimo che lo anima non è quello tradizionale, ma un movimento ultraconservatore che trasuda contro-rivoluzione nello spirito di de Maistre, il pensatore contro-illuminista che ha annunciato il Romanticismo. Per Vance, la politica non è tanto una competizione per la maggioranza quanto una lotta esistenziale tra il bene e il male.
Nel suo libro di memorie Hillbilly Elegy (2016), J.D. Vance racconta la sua infanzia con una madre tossicodipendente nelle miniere di carbone degli Appalachi, sentendosi inferiore perché l’establishment americano li guardava dall’alto in basso. Questi sentimenti hanno dato origine a un bisogno di autoaffermazione. Nella sua storia, scrive che non è stato lui a radicalizzarsi, ma la sinistra. Era stata la sinistra a trasformare le università in una monocultura intellettuale. Era stata la sinistra a trasformare gli Stati Uniti in una facciata di democrazia sotto uno Stato guidato da una burocrazia di esperti, il deep state, come Vance chiama il regime, che l’ideologo del movimento Curtis Yarvin chiama la Cattedrale e Peter Thiel, il filosofo tra i miliardari della tecnologia, chiama il Ministero della Verità. Tutti chiedevano una rivoluzione dall’alto sotto lo slogan RAGE, Retire All Government Employees (licenziare tutti i dipendenti pubblici). Yarvin, nato nel 1973, blogger e sviluppatore di software, era già all’inizio degli anni 2000, insieme a Nick Lane, forse la figura più importante di una comunità antidemocratica e antiegualitaria, piuttosto che di un movimento, una comunità digitale con slogan come destra alternativa, alt right, neo-reazionaria e illuminismo oscuro (Lane 2022, Yarvin 2024). Nelle loro apparizioni sui media erano orientati al futuro, ma traevano le loro visioni del futuro in modo peculiare dal passato. Curtis Yarvin era ispirato da Thomas Carlyle, l’idealista sociale del XIX secolo che vedeva la storia come la creazione di eroi. Essi sostenevano un ritorno alla monarchia in nuove forme, in cui una società sostituiva lo Stato sotto una gestione monarchica responsabile. Il nemico principale era tutto ciò che aveva a che fare con la democrazia, le idee liberali, l’illuminismo e l’idea di progresso. Ciò che è improvvisamente diventato una realtà politica con Trump 2, scioccando e sorprendendo tutti, si è sviluppato in un lungo processo di fermentazione sotto la superficie della democrazia che il dibattito pubblico in Occidente ha dato per scontato. Sotto Trump 1, il fermento è in qualche modo riemerso, ma è scomparso di nuovo sotto Biden. Quando i portavoce del nuovo ordine parlavano di politica neoreazionaria, non si riferivano al conservatorismo dei loro nonni o di Edmund Burke, ma all’accoppiata dei principi dell’ingegneria moderna con le idee antidemocratiche classiche nell’era di Internet 2.0. L’illuminismo e l’idea di progresso che ne seguì furono un errore. Il liberalismo democratico basato sugli ideali di libertà e uguaglianza deve essere visto attraverso gli occhi di Darwin.
Vance si allinea a queste idee quando collabora con Steve Bannon, consigliere di Trump durante il suo primo mandato, per costruire un movimento nazionalista di destra internazionale. Vogliono trasformare i populisti e gli estremisti di destra europei in uno strumento del MAGA, uno strumento sovversivo con un programma antiliberale, autoritario e paternalistico per ridefinire il potere popolare e distruggere la democrazia liberale e la sua più grande conquista: lo stato sociale. Putin esprime il suo obiettivo in modo non diverso, soprattutto da quando Trump ha aggiunto l’espansione imperialista all’agenda. Stanno emergendo due programmi politici che si sovrappongono, quello americano e quello russo. Da un lato, cercano il conflitto con l’Europa per attuarli. Dall’altro, cercano partner in Europa con lo stesso obiettivo.
La forza motrice e l’obiettivo di Donald Trump è rendere di nuovo grande l’America. Intende raggiungere questo obiettivo rivitalizzando la Rust Belt. L’attenzione è rivolta all’industria manifatturiera, in particolare all’industria automobilistica. I dazi, il cui importo sembra essere stato tirato a caso, hanno lo scopo di escludere i concorrenti e/o costringerli a stabilire fabbriche negli Stati Uniti. Dietro questo obiettivo c’è un modo di pensare mercantilista e statico. C’è una contraddizione. Le fabbriche che producono automobili e altri prodotti non solo generano occupazione, ma nel mondo globalizzato di oggi importano anche componenti i cui costi stanno aumentando vertiginosamente a causa dei dazi. E questi costi si riflettono in prezzi più elevati. Non è un caso che l’industria automobilistica statunitense abbia iniziato a licenziare personale quando Trump ha aumentato i dazi. La grandezza per cui Trump sta lavorando appartiene al passato. Se l’idea di fondo è quella di distruggere l’ordine mondiale esistente e il sistema politico statunitense, allora le contraddizioni tra Trump e gli oligarchi sono evidenti. Tuttavia, questo non diventa un problema, al contrario. Le contraddizioni e i conflitti interni contribuiscono alla confusione generale e creano caos. I produttori del dramma di Trump si stanno sfregando le mani dalla gioia.
Distruggere la democrazia europea è un obiettivo importante nella campagna dei tech oligarchi per un nuovo ordine mondiale. Il vicepresidente Vance, protetto di Peter Thiel, è il più eloquente e il collegamento dei tech oligarchi con Trump. La sua dichiarazione alla conferenza sulla sicurezza di Monaco nel febbraio 2025 non è stata una coincidenza. Quando nel maggio 2025 l’agenzia di intelligence interna tedesca ha consegnato al governo federale un rapporto di 1.100 pagine in cui si concludeva che il partito populista di destra Alternativa per la Germania è anticostituzionale ed estremista, Vance ha parlato in modo altisonante come aveva fatto a Monaco, sostenendo che il muro che gli Stati Uniti e la Germania occidentale avevano abbattuto nel 1989 era ora in fase di ricostruzione da parte del solo governo tedesco. Marco Rubio ha aggiunto che la Germania era una tirannia. Il vicepresidente e il segretario di Stato hanno ignorato il fatto che il rapporto era un documento ufficiale che non era stato elaborato politicamente quando, come Vance a Monaco, hanno dichiarato che una Germania democratica deve integrare pienamente l’AfD nel dibattito parlamentare. Qualsiasi altra cosa sarebbe antidemocratica. Vance promuove il mito della vera maggioranza democratica che include gli estremisti di destra e la falsa maggioranza creata nel mezzo, e lo fa usando la Germania come esempio.
La ridefinizione del concetto di democrazia da parte del vicepresidente va nella direzione del movimento völkisch degli anni ’30. I populisti di destra, ora estremisti di destra in Germania, stanno spingendo nella stessa direzione, dove il populismo e il governo del popolo sono uniti nei miti del passato. Si tratta di una visione pericolosa oggi come lo era nella Germania degli anni ’30. Vance sta portando avanti la campagna di Steve Bannon sotto Trump 1 per un’internazionale autoritaria e paternalistica di nazionalisti di destra e antiliberali, con il sostegno influente di Elon Musk e del segretario di Stato Rubio. L’obiettivo è la cooperazione in questa internazionale con i nazionalisti di destra europei, formatisi nel Parlamento europeo. Essi rappresentano ciò che il regime di Trump definisce il futuro democratico dell’Europa. Garantiranno alle piattaforme tecnologiche la completa libertà dalla regolamentazione in Europa. La loro grande speranza in Europa è Georgia Meloni, che sembra cercare di mantenere un equilibrio tra il concetto di democrazia dell’UE e il disprezzo delle aziende tecnologiche per la democrazia.
Le politiche di Trump sono in netto contrasto con l’agenda degli oligarchi tecnologici su questioni cruciali. Il loro futuro non è nella Rust Belt e nei giacimenti petroliferi. Sognano di colonizzare Marte e di viaggiare nello spazio e di raggiungere la vita eterna attraverso l’intelligenza artificiale (Peter Thiel). Non dicono nulla sull’occupazione, ma pensano a come l’IA possa sostituire i posti di lavoro. Sono chiari nel loro disprezzo per lo Stato profondo e il suo governo di esperti. Vogliono distruggerlo e sostituirlo con un’azienda completamente digitalizzata con gli oligarchi tecnologici al timone. La sorveglianza attraverso l’uso massiccio dell’IA sarà probabilmente parte dell’arsenale del governo. Trump sembra essere pienamente d’accordo con l’agenda degli oligarchi tecnologici e lo sta dimostrando assumendo Elon Musk per il lavoro di distruzione. Ma non è chiaro se comprenda le implicazioni e la portata del programma o il proprio ruolo in esso. La sua esperienza è quella di uno speculatore immobiliare e attore televisivo. Il licenziamento di Musk come capo distruttore dello Stato dopo meno di sei mesi dimostra anche che ci sono tensioni tra gli oligarchi e tra questi ultimi e Trump. In qualità di produttore automobilistico, Musk era contrario alla politica tariffaria.
Trump e gli oligarchi tecnologici sono uniti nei loro sforzi per trasformare gli Stati Uniti in un nuovo paradiso fiscale globale e introdurre zone senza legge nel mondo offshore, come descritto da Slobodian in Crack-Up Capitalism (2023). L’amministrazione Trump promuove il commercio di criptovalute e sostiene i casinò online e le piattaforme di scommesse. Con i suoi piani per una riserva strategica di criptovalute, Trump sta minando il dollaro come effetto non intenzionale. La forza trainante delle criptovalute è il desiderio di nascondere il denaro attraverso il riciclaggio e l’evasione fiscale. Tutto questo con l’obiettivo di rafforzare l’economia illegale globale. Gli Stati Uniti stanno abbandonando i negoziati internazionali sulla cooperazione fiscale e molte altre forme di cooperazione internazionale. Joseph Stiglitz (2025) vede un unico barlume di speranza: l’uscita degli Stati Uniti renderà più facile per il resto del mondo continuare il proprio lavoro sulla tassazione internazionale delle multinazionali nell’ambito del G20, dell’ONU e dell’OCSE senza gli Stati Uniti, che in precedenza erano stati il principale ostacolo al progresso.
Parallelamente al lavoro su questa società senza legge, digitalizzata e a bassa imposizione fiscale, dove regnano il caos e la legge della giungla senza l’intervento del governo, Trump sta cercando di creare ordine ricreando la società industriale il cui periodo di massimo splendore è ormai passato. Tuttavia, la crescita non viene più generata lì, ma nella produzione di servizi, in particolare quelli finanziari. Lì Trump vuole lasciare tutto senza regolamentazione, libero per l’arricchimento personale senza alcuna pretesa di autorità. L’ordine vale anche per i lavoratori della Rust Belt che chiedono a gran voce sicurezza e riconoscimento morale ed economico. Sono loro che sostengono il populismo come fonte di malcontento. Per loro, Trump vuole riportare la produzione industriale negli Stati Uniti.
Dal 2008, due parole chiave sono all’ordine del giorno: sociale e nazione. È stato il risultato della democrazia liberale dopo il 1945 riunirle nello Ssato sociale. Nella lotta per una ridefinizione ora in corso, gli sfidanti invocano un modello storicamente collaudato e molto più radicale di nazionalsocialismo. L’esperimento si è concluso con una catastrofe gigantesca. È sulle rovine di quella catastrofe che sono stati costruiti gli stati democratici del welfare. Tutte le forze devono essere mobilitate per impedire che diventino le nuove rovine. Tutti devono rendersi conto che forze potenti stanno lavorando per trasformarle proprio in questo. Non si tratta solo di pochi spin doctor e personaggi in cerca di notorietà. Si tratta delle forze oscure e profonde della distruzione che cercano l’apocalisse prima del passaggio al mondo dell’intelligenza artificiale, con il romanticismo della controrivoluzione come ideologia e la tecnologia digitale all’avanguardia come arma. Non si tratta, come sostengono gli uomini dell’oscurità, dello stato profondo con i suoi esperti. Quello è solo un ostacolo da superare.
Dietro gli ideologi e il loro portavoce politico, il vicepresidente Vance, ci sono gli oligarchi della tecnologia. Definirli ricchi è un eufemismo. I pensatori di spicco sono le eminenze grigie, il venture capitalist Marc Andreessen e l’enigmatico Peter Thiel, anche lui venture capitalist e con una formazione filosofica (Chafkin 2022, Thiel 2014). La filosofia di Thiel ha una dimensione teologica sviluppata sotto l’impressione del’antropologo della religione René Girard, che è stato suo mentore nelle profonde questioni della croce e della resurrezione, della rivelazione, dell’apocalisse e della trascendenza. Disruption è la parola d’ordine. Distruggere e superare i confini. La trascendenza è l’intelligenza artificiale che sostituisce gli esseri umani e, nella sua perfezione, raggiunge la vita eterna. Thiel non crede nella concorrenza liberale, ma piuttosto nel monopolio illiberale. Non ha alcun problema con il potere statale centralizzato e la violenza della polizia. Muoversi velocemente e rompere le cose, come dice Mark Zuckerberg. Si intuisce il filosofo della volontà e della superumanità, Friedrich Nietzsche, dietro questa nuova certezza di fede. Lo stesso Nietzsche che, nella sua visione ciclica del tempo, avvertiva anche che l’umanità avrebbe ripetuto i propri errori all’infinito senza imparare da essi: O Mensch, Gib acht (Nietzsche 1891), che Gustav Mahler ha musicato in modo così toccante nella sua Terza Sinfonia. Nietzsche può essere letto in modo selettivo con l’intenzione di negare la sua ambivalenza tra il ciclico e il trascendente. Il potenziale di caduta esiste in entrambe le versioni, quella trionfante e quella cauta. Il superuomo di Nietzsche emerge chiaramente quando Peter Thiel vede l’IA come lo strumento che rende possibile la vita eterna. Ma gli oligarchi tecnologici con il loro immenso potenziale di potere non sono solo sogni filosofici di rendere possibile l’impossibile, ma anche Elon Musk con la sua motosega, e i più terra terra Zuckerberg, Bezos e molti altri. Liquidare tutto questo come irrilevante per Trump sarebbe un grave errore. Sono loro che scrivono il copione e producono il dramma di Trump.
Il MAGA non dovrebbe essere visto come un’ideologia coerente, ma piuttosto come un discorso pieno di contraddizioni, in cui alcuni vogliono una posizione più dura nei confronti della Cina, mentre altri vogliono un approccio più morbido. L’Europa non è particolarmente rilevante, se non come Europa populista di destra ed estremista sotto il potere digitale degli Stati Uniti.
E ora, Europa?
La situazione geopolitica è cambiata radicalmente. O, per dirla meglio: l’ordine in disgregazione che veniva chiamato Occidente si è trasformato in geopolitica globale. Per l’Europa è tornato il fronte della Guerra Fredda, con l’eccezione fondamentale che l’Europa non ha più gli Stati Uniti alle spalle e che l’Europa occidentale è diventata un’Europa con maggiori responsabilità in materia di politica di sicurezza, ma anche con maggiori tensioni interne. La politica imperiale russa va oltre quella della Guerra Fredda, quando l’equilibrio del terrore nucleare imponeva una certa moderazione. Ora si tratta di guerra convenzionale con la minaccia delle armi nucleari che incombe sullo sfondo. Si teme che gli Stati baltici, la Georgia e la Moldavia diventino nuove pedine nelle ambizioni di Putin di ripristinare i confini dell’Impero Sovietico. Oltre l’Ucraina, ovviamente.
È questa situazione che ha portato Habermas a iniziare a ragionare in termini geopolitici, un campo inesplorato per lui, il che suggerisce quanto sia drammatico il cambiamento. Egli sostiene che l’Europa deve approfondire la sua cooperazione in risposta alla situazione e accusa Olaf Scholz di negligenza in questo senso come cancelliere. Habermas non contesta le argomentazioni a favore del riarmo militare, ma mette in guardia, alla luce della forza dell’AfD, dal rischio di una Germania militarizzata, ed è su questo punto che Habermas introduce l’Europa nel quadro. In un articolo che fa seguito al manifesto di Habermas, lo storico di Jena Norbert Frei chiarisce le argomentazioni generali di Habermas a favore di una cooperazione europea più intensa in materia di difesa. Sullo sfondo della crescita populista di destra, che sta causando disordini nel mondo circostante, ciò deve comportare una comunità europea di difesa del tipo che era stata discussa nel 1952-1954, al fine di poter utilizzare e allo stesso tempo vincolare la forza militare della Germania occidentale. L’europeizzazione della difesa sarebbe una risposta alle preoccupazioni europee sul riarmo tedesco (Frei 2025).
Si tratta quindi di tradurre l’Unione del carbone e dell’acciaio di Robert Schuman in ambito militare. Per i leader europei e l’opinione pubblica, si tratta di comprendere e identificarsi con l’enormità del compito di Robert Schuman nel 1950: convincere l’Europa della necessità di riarmare la Germania cinque anni dopo la guerra mondiale e realizzare il coraggio intellettuale che questo compito richiedeva. E rendersi conto che il compito è altrettanto incredibile oggi. Ma, come Schuman, essere convinti che l’incredibile è possibile, ma richiede azione.
La crisi transatlantica è fondamentalmente una crisi di fiducia innescata dalla mancanza di chiarezza del presidente degli Stati Uniti sul suo impegno nei confronti della NATO e sui suoi piani per la Russia. La fiducia perduta di fronte alle minacce esterne non può essere facilmente ripristinata. Il danno è duraturo per il prossimo futuro. La situazione richiede un’azione europea indipendente attraverso una cooperazione rafforzata. Ciò non significa che l’Europa debba ribellarsi agli Stati Uniti o lasciare la NATO, ma piuttosto che deve pensare al di là degli Stati Uniti nella sua pianificazione e preparazione. Si tratta in gran parte di un processo mentale che richiede un nuovo linguaggio. L’obiettivo della rottura deve essere il più possibile simile a un divorzio consensuale e il più silenzioso e discreto possibile, in modo da lasciare Putin almeno in una certa incertezza su ciò che sta accadendo. Ma deve essere chiaro e deliberato.
La rottura deve basarsi sulla convinzione di un’Europa sovrana, capace di agire con sicurezza, contando sulle proprie forze. L’immagine contraria che deve essere dissipata è quella diffusa in tutto il mondo dei quattro moschettieri Macron, Starmer, Merz e Tusk a Kiev per assicurare a Zelensky il loro pieno sostegno mentre chiamano Trump su un cellulare appoggiato sul tavolo e lo convincono a promettere pieno appoggio alla loro richiesta di cessate il fuoco. La promessa è stata infranta il giorno dopo e i quattro sono stati screditati. I moschettieri erano attori dell’impotenza che promuovano il disprezzo per i politici. Il compito che ci attende richiede coraggio intellettuale e morale, che deve tradursi in piani concreti per la sovranità digitale con alternative al GPS, ai servizi cloud odierni, alla regolamentazione di Internet e molto altro ancora. Allo stesso tempo, l’indipendenza politica deve essere combinata il più possibile con un sostegno più profondo alla cooperazione transatlantica all’interno della società civile, con le organizzazioni volontarie e all’interno della comunità di ricerca per rispondere agli attacchi dell’amministrazione Trump alle università e ai legami familiari e di amicizia. L’Europa deve sostenere come società civile le forze democratiche negli Stati Uniti.
Il riferimento di Frei ai piani di difesa europei degli anni ’50 non implica necessariamente una ripetizione dei lunghi e dettagliati negoziati di allora e delle deliberazioni sulla rinuncia alla sovranità nazionale. Non c’è abbastanza tempo per questo, né c’è una volontà europea sufficiente. Si tratta piuttosto di una coalizione di volenterosi per approfondire la cooperazione in materia di difesa. La coalizione dei volenterosi era, dopo tutto, l’espressione utilizzata dall’amministrazione Bush per indicare gli Stati europei che avevano aderito alla guerra in Iraq. Il compito è quello di ridefinire il suo significato in una lotta discorsiva per una nuova politica. Germania, Francia, Polonia, Regno Unito e i paesi nordici e baltici potrebbero formare un nucleo in questo approfondimento, dove è concepibile un maggiore impegno e dove l’approfondimento al di fuori del nucleo non deve necessariamente essere così grande.
Limitare i problemi che circondano il futuro dell’Europa al settore militare sarebbe un grave errore. Nel disordine internazionale che si sta sviluppando a seguito del crollo delle regole, che fa parte della politica di Trump e degli oligarchi tecnologici sotto la bandiera della disruption, cresce la necessità di un’Europa in grado di assumersi la responsabilità di sé stessa e del mondo che la circonda in modo nuovo. La situazione di crisi deve essere sfruttata per ristabilire regole e ordine e per consentire una politica globale coordinata contro il cambiamento climatico, un’alternativa alla guerra che distrugge l’ambiente e il clima. L’Europa deve trovare punti di contatto con la Cina, potenza mondiale leader nella tecnologia climatica e sostenitrice di un ordine internazionale basato sulle regole. In ogni caso, la Cina non è favorevole alla distruzione sistematica delle regole. Le differenze di opinione sulla democrazia sono significative, ma non possono costituire un ostacolo a una cooperazione più profonda sul clima e sulle regole internazionali nel breve termine. L’Europa è coinvolta in una corsa agli armamenti difficile da evitare, ma è importante trovare alternative con un focus diverso nella politica mondiale rispetto a quello che si sta sviluppando attualmente, e questo è forse anche nell’interesse della Cina. E in ogni caso è nell’interesse del pianeta. Sarebbe fatale essere trascinati nella spirale discendente degli Stati Uniti di cui Habermas mette in guardia.
In un potente discorso tenuto a Bruxelles l’8 maggio 2025, Etienne Balibar ha affrontato la questione “Cosa ora per l’Europa?”. Balibar e Habermas sono il tandem filosofico franco-tedesco non sincronizzato del continente, uno più neo/post-marxista e verde, l’altro più liberale illuminista, nella loro incessante argomentazione a favore di un’Europa diversa. La data del discorso era simbolica, l’80° anniversario della capitolazione di Reims e la vigilia del 75° anniversario del discorso europeo di Robert Schuman. Balibar (2025) ha lamentato l’ondata di populismo di destra che ha investito l’Europa negli ultimi dieci anni. Molti di coloro che fanno parte di questa ondata sono apertamente nostalgici del fascismo e del nazismo che hanno tormentato il continente negli anni ’20 e ’30, come se fosse giunto il momento di dimenticare dopo due o tre generazioni. Hanno un notevole potere parlamentare e discorsivo. Nella cooperazione europea, hanno un potenziale pericoloso. Xenofobi e con meschini progetti nazionalisti/imperialisti per il futuro, sono sia rivali che spiriti affini. Data l’epoca da cui traggono ispirazione, i tentativi di “civilizzarli” o “domarli” sono futili. Tutti i partiti populisti invocano la grandezza nazionale e rifiutano l’idea di definire la sovranità a livello europeo. Vogliono invece un modello europeo di alleanze geopolitiche e conflitti tra stati nazionali, con la xenofobia come importante forza motrice.
In Europa, la guerra in Ucraina sta delineando una nuova divisione, una Yalta 2. L’Europa deve fare i conti con una Russia espansionista costruita sull’ideologia di Putin di una Russia più grande. Sebbene Putin, a differenza di Napoleone e Hitler, non abbia la capacità di occupare l’intera Europa, i suoi piani comprendono il più possibile il vecchio impero sovietico, includendo non solo l’Ucraina ma anche gli Stati baltici. Inoltre, l’Europa deve fare i conti con il fatto che gli Stati Uniti accettino le ambizioni della Russia in cambio dell’accettazione da parte di quest’ultima di quelle statunitensi nell’Artico. Sebbene ideologicamente completamente diverse, è prevedibile una cooperazione russo-americana. In breve tempo, gli Stati Uniti si sono trasformati da centro globale del neoliberismo a potenza nazionalista/imperialista e neomercantilista. Le relazioni tra gli imperi russo e americano pongono all’Europa una sfida completamente diversa dalla competizione capitalista tra Stati Uniti e Cina, entrambi caratterizzati da un forte statalismo. Ciò solleva la questione di cosa accadrà allo statalismo americano, ma tale questione non altera il quadro generale di Balibar.
Tuttavia, Balibar afferma che la sua descrizione della situazione presenta un grave difetto. Non tiene conto della digitalizzazione e dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Gli algoritmi stanno cambiando radicalmente il discorso pubblico. Gli algoritmi stanno colonizzando le relazioni sociali. La descrizione della situazione trascura anche il cambiamento climatico e i disastri ambientali e la questione correlata di come dovrebbe essere organizzata la crescita economica nel Nord e nel Sud, osserva Balibar.
Dopo aver brevemente respinto Timothy Garton Ash, che ha sostenuto la necessità di un impero europeo come risposta a Trump e Putin, Balibar fa poi una sorprendente svolta verso Alan Milward, che all’epoca di Maastricht lanciò la tesi molto discussa secondo cui l’integrazione europea non riguardava un super stato europeo, ma il salvataggio dello stato-nazione, The European Rescue of the Nation-State (Milward 1992). Nel libro di Milward, Balibar trova «l’improbabile possibilità di un’Europa federale». In quell’Europa che ha salvato lo stato-nazione, senza il quale lo stato-nazione non sarebbe sopravvissuto. Contrariamente all’interpretazione del dibattito contemporaneo sulla distinzione tra Europa e stati-nazione, in cui il salvataggio degli stati-nazione era la questione principale, Balibar sottolinea l’Europa come salvatrice, fornendo così impulso a un nuovo dibattito sull’argomento. Balibar rende l’Europa il soggetto agente. Nel dibattito sulla tesi di Milward, gli stati nazionali erano i soggetti agenti, mentre l’Europa passava in secondo piano dopo averli salvati. Per quanto riguarda la definizione di federazione, Balibar non vede alcuna differenza fondamentale tra uno stato federale e una confederazione. Le due categorie si sovrappongono e l’esatto mix è più una questione di prospettiva storica che qualcosa di teleologicamente preprogrammato, più una questione di empirismo che di teoria.
Balibar sottolinea che il problema principale dell’UE nella sua forma attuale è che si tratta di un’UE di mercato, ma in modo diverso da quanto previsto nei negoziati di Maastricht sul mercato interno e certamente in modo diverso da quanto aveva in mente Milward. Il problema del Trattato di Maastricht è che non prevede l’integrazione sociale come controparte dell’integrazione economica. Delors lo voleva, ma la Thatcher si oppose con successo. L’idea di armonizzare norme e standard è stata trasferita al linguaggio del benchmarking, delle migliori pratiche e del metodo di coordinamento aperto, che hanno portato gli stati membri dell’UE a concentrarsi sulla concorrenza reciproca con pressioni sugli standard sociali, uno sviluppo che Mario Draghi critica nella sua relazione sulla competitività dell’UE presentata alla Commissione nel 2024. Attraverso la concorrenza interna, l’UE ha trascurato di unirsi per una concorrenza esterna comune, scrive (Draghi 2024). Questa negligenza potrebbe rivelarsi costosa nell’era degli imperi.
Con la sua osservazione che sono proprio le questioni sociali a guidare oggi i populisti e i nazionalisti europei, Balibar, nella sua rilettura di Milward e con il suo riferimento a Draghi, dà un contributo significativo al dibattito sul futuro dell’Europa. Egli aggiunge un punto importante all’appello di Habermas: un’Europa sociale contro l’agenda sociale dei nazionalisti. Con un’Europa forte al suo interno sulle questioni sociali, dove il grado di sovranazionalità non distrugge il dibattito, l’Europa può aprirsi in modo nuovo al Sud del mondo con una strategia alternativa alla competizione tra imperi che si sta svolgendo anche nel Sud. È auspicabile che le idee di Balibar stimolino il dibattito e l’azione in un’Europa che sta cercando a tentoni la sua strada alla ricerca di se stessa. La storia non è priva di alternative. La disintegrazione è anche un’opzione, se non si fa nulla per impedirla.
Traduzione di DeepL e Bo Stråth dallo svedese dell’articolo Bo Stråth, «En världsordning i upplösning. Vad nu? 1. Imperiernas möte i Europa och Europas svar.» Statsvetenskaplig Tidskrift Vol 127 Nr 2 giugno 2025.
A seguire:
“Un ordine mondiale in dissoluzione. E adesso? 2. Democrazia a bassa intensità senza alternative, nichilismo e il potere degli algoritmi.” Settembre 2025
“Un ordine mondiale in dissoluzione. E adesso? 3. Un’Europa basata sui valori in un’epoca nichilista. Verso un nomos per una società globale.” Dicembre 2025
Riferimenti:
Balibar, Etienne, 2025. “L’impossible possibilité de la fédération européenne: hier, aujourd’hui, demain.” Public lecture, Institute for European Studies, Free University of Brussels, “Europe Day,” May 8, 2025.
Chafkin, Max, 2022. The Contrarian. Peter Thiel and Silicon Valley’s Pursuit of Power. Bloomsbury.
Draghi, Mario, 2024. The Draghi Report: Part A. A competitiveness strategy for Europe. Part B. Analysis and Recommendations. Brussels: European Commission, September 9, 2024.
Frei, Norbert, 2025. “Der Westen, wie wir ihn kannten, ist weg” (The West as we knew it is gone), Süddeutsche Zeitung, 23 March 2025.
Fukuyama, Francis, 1992. The End of History and the Last Man. New York: Free Press.
Gilman, Nils, 2025. “A Planetary Geopolitical Realignment?”, Substack/Small Precautions, 19 March 2025.
Habermas, Jürgen, 2025. “Für Europa”. Süddeutsche Zeitung, 21 March 2025.
Heritage Foundation, 2024. “Project 2025 Mandate for Leadership. The Conservative Promise”. Available at https://archive.org/details/2025_MandateForLeadership_FULL.
Huntington, Samuel, 1996. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.
Huntington, Samuel, 2004. Who Are You? Who Are We? The Challenges to America’s National Identity. New York: Simon & Schuster.
Kagan, Robert, 2003. Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order. New York: Knopf.
Kagan, Robert, 2024. Rebellion. How Antiliberalism Is Tearing America Apart Again. London: W H Allen.
Land, Nick, 2022. The Dark Enlightenment. Imperium Press.
Milward, Alan, 1992. The European Rescue of the Nation-State. London: Routledge.
Nietzsche, Friedrich, 1891. Also sprach Zarathustra. Vol. 4. Leipzig
Nussbaum, Emily, 2024. Cue the Sun! ‒ The Invention of Reality TV. New York: Random House.
O’Toole, Fintan, 2025. “Shredding the Postwar Order,” New York Review of Books, 2025-04-24.
Slobodian, Quinn, 2023. Crack-Up Capitalism: Market Radicals and the Dream of a World without Democracy. London: Allen Lane.
Stiglitz, Joseph, 2025. “Trump’s America: The New Global Tax Haven?”, Social Europe, 2025-04-30.
Stråth, Bo & Trüper, Henning, 2025. “Conceptualizing Capitalism: Conversations with Henning Trüper. Blog 4. The Zeitgeist of Empire and Nihilism in Historical Perspective. And Capitalism?” Available at https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/conceptualizing-.
Thiel, Peter, 2014. Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future. New York: Random House.
Vance, J D, 2016. Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis. Blackstone.
Weber, Max 1980 [1922]. Wirtschaft und Gesellschaft. Ed. Johannes Winckelmann: Tübingen: Mohr.
Westad, Odd Arne, 2005. The Global Cold War. Cambridge: Cambridge University Press.
White House, 2025-02-14. Vice President JD Vance Delivers Remarks at the Munich Security Conference. Available at https://www.com/watch?v=pCOsgfINdKg
White House statement, 2025-04-07. Available at https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/04/cea-chairman-steve-miran-hudson-institute-event-remarks/CEA Chairman Steve Miran Hudson Institute Event Remarks – The White House.
Yarvin, Curtis, 2024. Gray Mirror. Fascicle I: Disturbance. Passage Press.
Come citare:
Cit. Bo Stråth, “Un ordine mondiale in dissoluzione. E adesso? 1. L’incontro degli imperi in Europa e la risposta dell’Europa.” Blog. https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/un-ordine-mondiale-in-dissoluzione-e-adesso/ Published 06.07.2025
Comments
Please submit you comments with the Contact Form or send an Email to bo.strath@gmail.com.