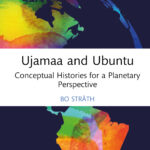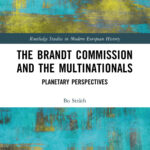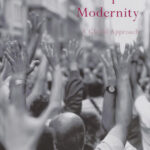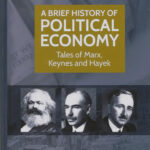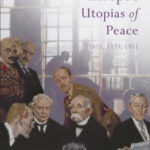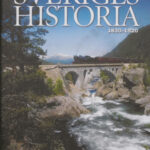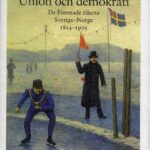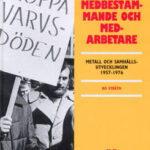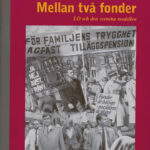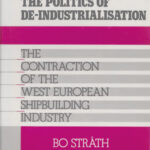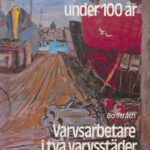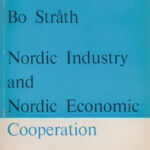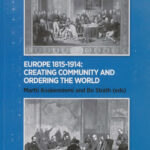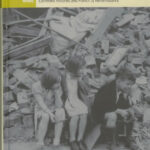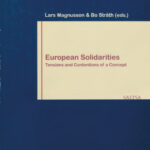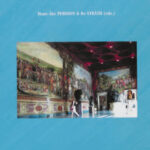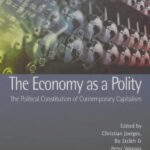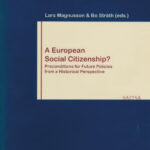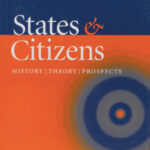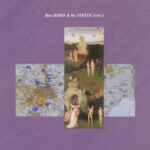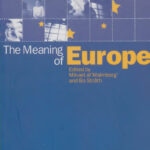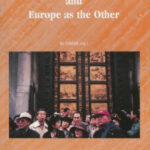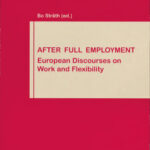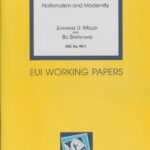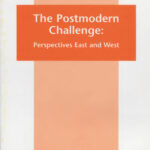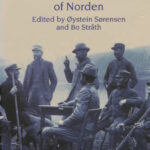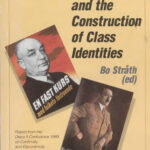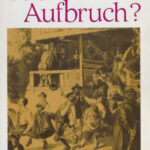Il punto di partenza: una breve saga occidentale culminata negli anni ’60
Sarebbe sbagliato discutere degli sviluppi negli Stati Uniti dal 2016 come di un problema esclusivamente americano. Gli eventi negli Stati Uniti dal 2016, che hanno subito un’accelerazione dal 2025, si svolgono sullo sfondo di uno zeitgeist globale più generale caratterizzato dall’erosione della democrazia, dal nuovo-vecchio imperialismo intorno alle idee di geopolitica e geoeconomia e dal nichilismo dei valori, dove le convinzioni sui valori stabili vengono dissolte dalle forti emozioni nei social network digitali. Le democrazie si stanno trasformando in forme di governo autoritarie e paternalistiche. L’etichetta “illiberale” sfida le nozioni liberali di democrazia. Queste tendenze sono interconnesse e si rafforzano a vicenda. È proprio questo generale declino, da cui è scaturita la valanga americana nel novembre 2024/gennaio 2025, che Jürgen Habermas (2025; cfr. Stråth 2025) avverte potrebbe verificarsi anche in Europa se i suoi leader non adottano attivamente delle contromisure.
La democrazia in senso moderno, il suffragio universale per uomini e donne e un sistema parlamentare con un’influenza sostanziale sul contenuto della politica, hanno fatto la loro comparsa negli anni ’20 dopo la mobilitazione di massa per la Prima guerra mondiale. La democrazia come ideale e la lotta per la democrazia sono più vecchie. La svolta ha riguardato una parte limitata del mondo, i paesi industrializzati. La mobilitazione di massa per la Seconda guerra mondiale ha approfondito la sostanza politica del lavoro parlamentare con idee di welfare universale organizzato dallo Stato, ma in un mondo limitato a quello che veniva chiamato Occidente: Stati Uniti, Europa occidentale e Giappone (dopo il 1945). L’espansione degli Stati sociali nell’Europa occidentale negli anni ’60 può essere vista come un’età dell’oro democratica. Il centro della politica erano i parlamenti. È il periodo che il politologo irlandese Peter Mair (2013), in un libro pubblicato postumo, considera il culmine della democrazia, quando iniziò anche il declino. Fino ad allora, la politica era stata basata sugli interessi e guidata ideologicamente dai conflitti di interesse che si erano sviluppati nella società industriale. Questi interessi e le loro ideologie hanno sviluppato identità sociali che si scontravano tra loro nei parlamenti nazionali. Il lavoro di compromesso ha dato origine a identità nazionali che hanno sia colmato che perpetuato i conflitti di interesse.
Se la prima guerra mondiale ha portato alla svolta della democrazia, la seconda guerra mondiale ha portato alla sua perfezione in una piccola parte del mondo, sotto forma di Stati sociali occidentali a economia mista con consumo di massa e produzione di massa in una dinamica che si rafforzava a vicenda. La teoria economica di Keynes ha legittimato il sistema. La teoria enfatizzava la stimolazione della domanda politica. La crescita ha fornito una torta in continua espansione che ha facilitato la politica di distribuzione utilizzando la tassazione progressiva come strumento. Il welfare era anche uno strumento ideologico nella Guerra Fredda, una vetrina contro il socialismo di Stato nell’Europa orientale. C’era una forte convinzione che ciò che era stato visto come ingegneria sociale avesse trovato un ordine permanente. Ma nessuno credeva che la storia fosse giunta al termine. La Guerra Fredda minacciava di distruggere tutto.
La democrazia che rompeva gli interessi e cercava il compromesso, che Mair vedeva culminare negli anni ’60, si basava su una disciplina sociale creata sotto la pressione della guerra mondiale, una disciplina sociale per la coesione nazionale. Continuò durante il terrore nucleare della Guerra Fredda. La pressione si attenuò dopo le successive crisi del Congo, di Berlino e di Cuba del 1960-1962. Dopo Cuba, l’abisso non sembrava più così vicino. La disciplina sociale si allentò, con il “1968” come segno visibile. Aumentarono anche i conflitti sulla distribuzione (Stråth e Trüper 2025). Il “1968” fu una rivolta generazionale con proteste contro il consumo di massa, l’eccesso e la distruzione dell’ambiente. I manifestanti chiedevano giustizia globale e maggiore sostegno ai paesi in via di sviluppo. La protesta si diffuse in tutto il mondo occidentale con enfasi diverse. In Germania, si trattava di fare i conti con il modo in cui la vecchia generazione aveva permesso e sostenuto il nazismo; in Francia, l’obiettivo erano i mandarini delle università e lo stile autoritario di De Gaulle; negli Stati Uniti, era la guerra del Vietnam. Le proteste occidentali ispirarono la Primavera di Praga in Cecoslovacchia, che portò l’Unione Sovietica a intervenire con la forza militare. Il movimento sindacale occidentale radicalizzò la questione della distribuzione e mise in discussione lo spirito di consenso che aveva prevalso fino a quel momento, volto a impedire che i conflitti di interesse degenerassero in modo incontrollabile. Si levarono voci a favore della cogestione e della democrazia aziendale con una nuova visione della proprietà. In sintesi, la pressione sulla democrazia aumentò dall’interno mentre diminuiva dall’esterno durante la Guerra Fredda.
Pochi anni prima del “1968” iniziò la transizione che Peter Mair identificò come un passaggio dal compromesso ideologico e di interesse sulla questione della distribuzione alla professionalizzazione e tecnocratizzazione della politica, che significò anche una deideologizzazione. Le nuove teorie delle scienze sociali sullo Stato sociale e sulla comunità sociale legittimarono questo sviluppo. I partiti politici hanno iniziato a cercare di massimizzare i propri voti al di fuori dei propri gruppi di interesse, indebolendo così sia la definizione degli interessi che la loro forza motrice ideologica. La base dei compromessi parlamentari è diventata più difficile da comprendere. La politica è diventata amministrazione tecnocratica e governo di cartello, che ha eliminato la vera opposizione con la dissoluzione delle differenze significative tra i partiti. La radicalizzazione può essere vista come una protesta contro la deideologizzazione e la tecnocratizzazione in un momento in cui le circostanze esterne, la Guerra Fredda, rendevano possibile la lotta ideologica.
Quando gli Stati Uniti annunciarono una domenica di agosto del 1971 che non potevano più mantenere l’impegno di Bretton Woods di ancorare il dollaro a un prezzo fisso dell’oro, le condizioni della protesta cambiarono radicalmente. Il crollo del dollaro portò a un rapido aumento dell’inflazione, che indusse i produttori mondiali di petrolio, la maggior parte dei quali nel sud povero, ad aumentare drasticamente i prezzi. Le spedizioni di petrolio diminuirono e il loro futuro divenne incerto. La costruzione di superpetroliere crollò. L’industria cantieristica, così come i suoi numerosi fornitori nel settore siderurgico e in altri settori, cadde in una crisi strutturale con disoccupazione di massa. Fu una crisi di quello che era noto come il regime di produzione fordista delle catene di montaggio e del lavoro a cottimo. L’aumento del prezzo del petrolio sconvolse e colse di sorpresa i leader politici occidentali, che si trovarono in una crisi sistemica. L’ondata radicale della fine degli anni ’60 giunse al termine.
Il Terzo Mondo riprese da dove “il 1968” e la radicalizzazione della classe operaia avevano lasciato. I suoi leader vedevano il petrolio come un esempio per altre materie prime. Uniti nel G77, chiesero un Nuovo Ordine Economico Internazionale (NOEI) con prezzi più alti delle materie prime e opportunità di nazionalizzare le aziende occidentali nei paesi in via di sviluppo (in cambio di un risarcimento). Per alcuni anni (1973-75), fecero dell’ONU l’arena principale per negoziare le loro richieste con i paesi industrializzati. Al conflitto Est-Ovest della Guerra Fredda si aggiunse un conflitto Nord-Sud. I leader occidentali allarmati fondarono il G7 per scongiurare la minaccia del G77 (Stråth 2023: 109-115).
Questa fu la situazione che portò i datori di lavoro e i detentori di capitali ad abbandonare definitivamente l’autodisciplina che la Guerra Fredda aveva loro imposto. A quel punto, seguirono i lavoratori radicali che avevano chiesto una maggiore influenza sulle aziende, ma ovviamente con obiettivi diversi. Il NOEI, con le sue richieste di opportunità di nazionalizzazione delle aziende, fu, oltre alla radicalizzazione dei lavoratori dell’Europa occidentale, un ulteriore incentivo ad abbandonare la politica della negoziazione e contrattazione tripartita (governi, datori di lavoro, sindacati) per risolvere il conflitto di interessi.
La crisi del regime di produzione fordista diede origine a nuovi modi di concepire la produttività e il profitto. Il futuro era nella produzione di servizi finanziari. Si avanzarono forti richieste per la loro internazionalizzazione, lontano dal controllo dei governi nazionali. Iniziò la svolta neoliberista. In Occidente, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, sostenuti dalle teorie economico-politiche di Friedrich Hayek e Milton Friedman, guidarono la rottura con l’ordine occidentale del dopoguerra stabilito a Bretton Woods nel 1944, che aveva costituito la base per diversi decenni di funzionamento della democrazia sociale, che aveva funzionato così bene che molti credevano fosse garantita per il futuro.
Negli Stati Uniti, anche Samuel Huntington individuò una svolta negli anni ’60, ma di tipo diverso, quando a metà degli anni ’70 rifletté sul crollo del dollaro nel 1971-73 e sulla crisi globale che ne seguì (Crozier, Huntington e Watanuki 1975). Le masse chiedevano troppo, sosteneva. La democrazia stava alimentando richieste che superavano le capacità finanziarie dello Stato. Huntington propose un equilibrio tra vitalità democratica e capacità di governo attraverso una riduzione delle opportunità democratiche. Si potrebbe anche dire che voleva ripristinare la disciplina sociale. Huntington fornì argomenti a favore della narrativa neoliberista emergente, in cui la restrizione fiscale diventava uno strumento per raggiungere il pareggio di bilancio e tagli fiscali come stimolo economico, piuttosto che la spesa pubblica raccomandata dal manuale keynesiano. Secondo Huntington, la democrazia dovrebbe essere concepita in modo da concentrarsi più sulla forma che sulla sostanza. Questa argomentazione si conciliava facilmente con l’orientamento neoliberista della politica e dell’economia degli anni ’70. Il problema dal punto di vista democratico era chi dovesse essere tenuto ad esercitare l’autodisciplina e chi dovesse esserne esentato. Tuttavia, Huntington non lo formulò in questi termini.
La svolta neoliberista
La svolta neoliberista degli anni ’80, rafforzata fino a diventare quasi egemonica negli anni ’90, era strettamente legata al passaggio dalla produzione di beni industriali ai servizi finanziari come motore della crescita, in particolare attraverso la deregolamentazione e l’internazionalizzazione dei mercati dei capitali e del credito e del commercio di valute. Investire nel denaro è diventato il motto che ha portato a crescenti disparità di reddito e ricchezza, allontanandosi da ciò che aveva caratterizzato gli Stati sociali keynesiani del dopoguerra. Il commercio speculativo di valuta ha esercitato pressioni sui governi degli Stati nazionali che avevano combinato le loro politiche keynesiane di stimolo della domanda con un rigoroso controllo dei mercati del credito e del commercio di valuta. Quando questa nuova libertà è stata successivamente combinata con la tecnologia digitale per leggere le tendenze e prendere decisioni speculative di vendita o acquisto con transazioni in nanosecondi, la pressione sui governi è aumentata ancora di più.
Il primo ministro svedese Ingvar Carlsson e il ministro delle finanze Kjell-Olof Feldt sono buoni esempi di una situazione più generale che ha colpito in particolare i partiti socialdemocratici europei e ha innescato tensioni tra i capi di governo e i ministri delle finanze anche nell’era pre-digitale. Rolf Gustavsson ha descritto come, dopo la vittoria elettorale del 1988, il tono delle conversazioni tra loro si sia inasprito in termini di opinioni sull’economia e sulle possibilità di una politica orientata alla domanda. Il primo ministro ha avuto uno scatto d’ira:
Cosa sta succedendo in questo Paese? Il governo ha lottato per portare a termine un processo di bilancio in cui abbiamo lavorato duramente per ridurre a zero l’aumento della spesa al fine di mantenere l’equilibrio dell’economia svedese. Allo stesso tempo, le banche stanno riversando denaro sui loro clienti per aumentare i consumi. Non si può aprire un giornale senza vedere enormi pubblicità di prestiti a basso interesse. Non c’è da stupirsi che l’economia sia in surriscaldamento (Gustavsson 2010:51).
Col senno di poi, Carlsson ha descritto la deregolamentazione del mercato del credito come il suo più grande errore durante i suoi sette anni come primo ministro. Col senno di poi, Feldt ha ammesso di aver sottovalutato le conseguenze della deregolamentazione, ma allo stesso tempo ha affermato che non c’era altra scelta (Gustavsson 2010: 50-55).
La liberazione dei detentori di capitali dalle barriere nazionali ha costretto i governi a esercitare moderazione nella spesa pubblica. I grandi deficit hanno portato ad un aumento dei tassi di interesse sui prestiti che li finanziavano, il che a sua volta ha ridotto lo spazio per nuove visioni per il futuro e politiche creative. La politica si è concentrata sempre più sulla gestione amministrativa delle risorse all’interno di determinati quadri.
Ciò che è interessante nelle opinioni dei due socialdemocratici è la posizione del ministro delle finanze, secondo cui non aveva scelta, e l’opinione del primo ministro, secondo cui si è pentito della sua decisione, il che significa che riteneva di avere una scelta. Bisogna concordare con Carlsson sul fatto che, ovviamente, c’era una scelta. Ma la domanda è: a quale costo per un piccolo paese rimanere fuori da una tendenza internazionale che era considerata l’unica strada giusta da seguire? La politica fiscale contro i mercati internazionali dei capitali non era un compito facile. L’egemonia emergente del quadro interpretativo neoliberista rendeva difficile resistere alla pressione per la deregolamentazione e l’internazionalizzazione. In Francia, François Mitterrand tentò di continuare con le politiche keynesiane nel 1981-83, ma la reazione dei mercati finanziari lo costrinse ad abbandonare il tentativo. Una volta avvenuta la deregolamentazione, i governi rimasero vulnerabili alle opinioni degli operatori di mercato, il che limitò il loro margine di manovra. Qualunque cosa facessero, gli operatori finanziari (“il mercato”) li mettevano in una camicia di forza.
Più di chiunque altro, Margaret Thatcher è associata al TINA, there is no alternative (al mercato). Dopo il 1990, la frase è diventata sempre più uno slogan guida. Il suo uso non comportava alcuna riflessione più approfondita su chi fosse il mercato. Il mercato è diventato un feticcio, un’astrazione che si è concretizzata nell’incapacità politica di agire. Le forze dietro la mistificazione del mercato non esitavano a colpire se ritenevano che i governi agissero in modo sbagliato. In questo modo, agivano come un banco di pesci. Il cambiamento nel controllo dei tassi di cambio e dei tassi di interesse ha avuto ripercussioni politiche significative. Margaret Thatcher rafforzò l’impressione di una democrazia sempre più impotente con l’argomento che non c’era alternativa alle richieste del mercato. La tendenza alla professionalizzazione e alla tecnocratizzazione della politica nelle democrazie occidentali osservata da Peter Mair negli anni ’60 accelerò, non perché la politica riguardasse l’amministrazione del welfare volta a massimizzare i voti, ma perché non c’erano alternative ai dettami del “mercato”. Il conflitto politico e la competizione tra alternative con visioni diverse del futuro scomparvero quando tutti si riunirono in una sorta di cartello politico di centro. Inizialmente, l’obiettivo era quello di massimizzare i voti, ma dopo il 1990, con l’avvento del neoliberismo, questo obiettivo fu combinato con l’adattamento al mercato. Il termine “post-politica” è stato coniato per descrivere questo sviluppo. Quando le proteste contro questo assetto sono cresciute e i partiti tradizionali non sono stati in grado di affrontare il malcontento, poiché non c’erano alternative al tradizionale “tirare avanti” tecnocratico, sono emersi imprenditori politici in grado di affrontare la frustrazione (Pepijn 2019). Si trattava dei paternalisti autocratici descritti da Stephen Hanson e Jeffrey Kopstein (2024) nel primo articolo di A World Order in Disarray (Stråth 2025) Link al blog 1 World Order in Dissolution English, con Donald Trump come coronamento.
Colin Crouch (2009) ha descritto come le politiche di bilancio keynesiane incentrate sulla domanda dei governi abbiano progressivamente ceduto il passo alle banche private che stimolavano la domanda attraverso il credito, il che è andato di pari passo con la privatizzazione di una serie di servizi statali e municipali in settori quali l’istruzione e la sanità. Crouch ha teorizzato sulle esperienze di Ingvar Carlsson e di molti altri leader politici. Crouch parla di keynesismo privatizzato. La crescente passività degli Stati ha portato a una privatizzazione della stimolazione della domanda dai bilanci statali a nuove forme di credito, in particolare le carte di credito.
In un centro politico annacquato e deideologizzato, o egemonico altamente ideologizzato, se volete, c’era un consenso generale sul fatto che i parlamenti fossero soggetti alle richieste del mercato. La narrativa della globalizzazione neoliberista, che è stata egemonica dopo il 1990 fino al crollo del 2008, ha legittimato l’ordine senza troppe discussioni. Come già detto, non c’era alternativa. Al di là della superficie discorsiva, i mercati del lavoro hanno subito cambiamenti fondamentali, non da ultimo in termini di rappresentanza degli interessi, in particolare della rappresentanza sindacale, con grandi gruppi di lavoratori precari a basso reddito che sono rimasti esclusi dal sistema di welfare. Anche i mercati finanziari hanno subito cambiamenti fondamentali attraverso la loro quasi completa internazionalizzazione, che ha avuto un effetto a catena sulle restrizioni di bilancio dei governi nazionali. Il rovescio della medaglia della narrativa della globalizzazione, la ridotta libertà d’azione dei governi nazionali e l’emergere di un precariato transnazionale, è scomparso sotto l’egemonia della narrativa.
Democrazia a bassa intensità
Susan Marks (2000) è stata una delle prime autrici a contribuire a una più ampia letteratura che mostra come la democrazia neoliberista sia diventata a bassa intensità: formale, con suffragio universale ma senza molta influenza sulla sostanza della politica. È stata questa forma a diffondersi in tutto il mondo con la narrativa della globalizzazione, dove la democrazia sotto il mercato era la forma di governo che diventava sempre più comune. L’economia neoliberista andava di pari passo con la democrazia neoliberista, una nuova forma di democrazia rispetto a quella che aveva costruito gli Stati sociali. La vivace critica sociale degli anni ’60 scomparve e la natura del dibattito pubblico cambiò. La norma e la nomenclatura per definire la democrazia si basavano su criteri formali come il suffragio, le elezioni generali libere e segrete, la libertà di espressione, ecc., ma non si diceva nulla su come gli elettori potessero influenzare la sostanza politica di questioni come la giustizia sociale e il welfare. Le crescenti divisioni sociali sulla scia della globalizzazione sono state tralasciate. Marks mostra come elezioni libere ed eque abbiano lasciato intatte le concentrazioni di potere e le ingiustizie sociali più profonde. Sostiene inoltre che l’ideologia che circonda la democrazia a bassa intensità essenzializza il concetto di democrazia a bassa intensità polarizzandolo contro la non democrazia piuttosto che contro la precedente forma più orientata alla sostanza. Parla di escapismo teleologico quando sostiene che i diritti politici degni di questo nome, e non solo la forma, devono venire prima dei diritti economici e sociali, e che i diritti politici riguardano la capacità di plasmare il futuro e cambiare ciò che è percepito come sbagliato. Per diritti politici intende la capacità di influenzare il contenuto della politica, non solo di applaudire in segno di approvazione.
Andrew Lang (2011), che, come Marks, scrive da una prospettiva di diritto internazionale, sostiene la tesi dello sviluppo di una democrazia formale a bassa intensità come nucleo politico della svolta neoliberista, la depoliticizzazione della politica. Gli anni ’90 hanno visto una forte espansione della democrazia nel mondo sulla scia del crollo dell’impero sovietico. Questa espansione ha riguardato molto più dell’Europa orientale. Società civili con movimenti democratici e il rovesciamento di governanti autocratici sono emerse quasi ovunque in America Latina, Africa, Asia e Medio Oriente. I media hanno gioito per la caduta dei regimi autoritari e la svolta della democrazia, che è andata di pari passo con il trionfo della narrativa della globalizzazione neoliberista.
Nei commenti accademici critici emersi dopo il 2000, il termine “bassa intensità” esprimeva lo stesso concetto del termine “senza alternative”. La bassa intensità era il concetto critico della revisione accademica dall’esterno del processo politico, mentre “senza alternative” era il concetto disciplinante dall’interno dei leader politici. Il significato di entrambi era che la democrazia nella sua forma neoliberista era più una questione di forma che di sostanza ed era fondamentalmente un’espressione di depoliticizzazione. La democrazia che era stata annacquata in Occidente sotto il concetto di “senza alternative” era esistita solo per pochi decenni dopo la Seconda guerra mondiale, ma si basava su un secolo e mezzo di lotte iniziate negli anni ’30 dell’Ottocento come contro-movimento agli aspetti negativi dell’industrializzazione e alla mobilitazione delle popolazioni per due guerre mondiali. L’idea degli anni ’90 che la democrazia, così come si era affermata in Occidente dopo il 1945, si sarebbe diffusa in tutto il mondo mentre veniva svuotata di significato in Occidente era, ovviamente, un’illusione che è stata abilmente nascosta sotto la potente narrativa della globalizzazione. Nessuno voleva vedere che c’era una differenza tra democrazia e democrazia.
Samuel Moyn (2010, 2018) ha mostrato come i diritti umani abbiano seguito la democrazia nell’erosione della sostanza e nella concentrazione sulla forma. Un diritto umano importante è diventato la protezione della proprietà, mentre i diritti sociali erano inconsistenti. Le multinazionali sono diventate soggetti coperti dai diritti umani. Si intuisce che dietro questa posizione ci sono le richieste dei paesi in via di sviluppo di opportunità di nazionalizzare le aziende. Moyn parla dei diritti umani nel vortice neoliberista (Moyn 2018: 173; cfr. Stråth 2023: 161). Nel diritto internazionale, c’è stato un passaggio dagli Stati agli individui come soggetti giuridici, per cui anche le aziende come persone giuridiche sono state equiparate agli individui come persone fisiche.
La democrazia a bassa intensità ha evitato di affrontare il conflitto di interessi nel mercato del lavoro, e le questioni della democrazia aziendale e della ridistribuzione sono scomparse dal dibattito. Gran parte dei mercati del lavoro sempre più segmentati sono stati esclusi dalla rappresentanza degli interessi. Il conflitto di classe è scomparso dalla teoria democratica. Le idee su una società consensuale senza classi hanno accompagnato i crescenti segni di emarginazione sociale e disgregazione sociale. Dani Rodrik (2000) parla del trilemma della globalizzazione, in cui lo Stato nazionale, la democrazia e il mercato senza frontiere formano un triangolo, ma solo due di essi possono coesistere. Rodrik descrive contesti teorici piuttosto che empirici: la democrazia e lo Stato nazionale non possono funzionare con un mercato senza frontiere. La democrazia e un mercato senza frontiere non possono funzionare con gli Stati nazionali come sede della democrazia. Gli Stati nazionali non possono essere democratici se il mercato è senza frontiere.
Paternalismo autocratico
Il crollo neoliberista in una bolla speculativa americana nel 2008, gonfiata dalla fiducia ingenua e senza confini del mondo nel dollaro, ha provocato uno shock a seguito dei massicci pacchetti finanziari stanziati dai governi per salvare le banche speculative, troppo grandi per fallire. La politica è rimasta senza alternative nel senso thatcheriano, ovvero dettata dal mercato. Si sono formate opinioni che si concentravano sui perdenti della globalizzazione. L’egemonia riguardava i vincitori come percorso verso il successo per tutti. L’economista greco Yanis Varoufakis (2011: 135), che è stato anche ministro delle finanze per un certo periodo, ha formulato la differenza tra vincitori e perdenti: “I ricchi… avevano scoperto un modo ingegnoso per arricchirsi: negoziare titoli cartacei che racchiudevano i sogni, le aspirazioni e l’eventuale disperazione dei più poveri della società”. I perdenti hanno espresso la rabbia popolare e il disprezzo per i politici nei confronti dei partiti tradizionali e dei loro rappresentanti. Quando gli imprenditori politici hanno iniziato a canalizzare con successo questo malcontento, si sono concentrati sulla nazione come perdente della globalizzazione che doveva essere ricreata. È sorta una protesta nazionalista populista, diretta contro l’establishment politico che aveva gestito la globalizzazione, i “cosmopoliti” e i “globalisti”. Utilizzando concetti come la democrazia illiberale, i leader con ideali autoritari hanno intrapreso la lotta contro la democrazia neoliberista. Il paternalismo si è diffuso come stile di governo, come hanno osservato Hanson & Kopstein (2024) e altri in una ricca letteratura di ricerca (vedi, ad esempio, Levitsky & Ziblatt 2018 e Lewis 2018). A ciò hanno fatto seguito argomenti più radicali su uno Stato profondo in cui gli esperti soffocavano l’iniziativa e altre teorie cospirative, come documentato da Hansson & Kopstein (2024) in un capitolo intitolato “The Deep State Bogeyman” (Lo spauracchio dello Stato profondo). È questo sviluppo che fa da sfondo agli Stati Uniti di Trump descritti nella prima parte d’Un Ordine Mondiale In Dissoluzione (Stråth 2025).
Le reazioni al crollo finanziario e al massiccio salvataggio con il denaro dei contribuenti hanno spinto la politica verso destra sotto forma di populismo e paternalismo autoritario che hanno sfidato l’amministrazione parlamentare di una politica che si diceva non avesse alternative. Dal 1990, tutti si erano schierati attorno al principio di un centrocampo immaginaria definito dal mercato e da quelle che si diceva fossero le sue esigenze. Fino al trionfo della politica senza alternative, la linea di conflitto parlamentare correva tra la destra e la sinistra, entrambe definite dall’ideologia e dagli interessi. Il conflitto e il compromesso tra loro tenevano insieme il centrocampo. Il punto è che i compromessi si basavano su divisioni ideologiche e definite dagli interessi, che rafforzavano centrocampo che ora erano soffocate da quello che si diceva essere un mercato senza alternative. Lo spazio di negoziazione che rafforzava la democrazia è scomparso. Dopo il 2008, la linea di conflitto è riapparsa, ma ora non al centro, bensì a destra del centrocampo, una linea che per molto tempo ha rappresentato un confine, un firewall o una linea di negoziazione. Il cambiamento è verso la linea di negoziazione tra la destra moderata e la destra populista. È attorno a questa linea che Marie Le Pen ed Emanuel Macron giocano al gatto e al topo su chi sia il centro e chi sia la destra, dividendo la nazione. I tentativi di entrambi di unificarla la rendono altamente polarizzata. Nel principio di massimizzazione dei voti che si applica, il sedicente centro adotta verbalmente la retorica populista di destra e sposta la sostanza politica a destra, ma sostiene che sia migliore perché proviene dal centro o dalla sinistra. Nel complesso, si assiste a uno spostamento verso destra delle norme, del linguaggio e della sostanza politica. La questione dell’immigrazione è il catalizzatore.
La Francia è solo uno dei tanti esempi. Il modello è visibile nell’UE, dove il leader dei partiti conservatori nel Parlamento europeo, il PPE, Manfred Weber, sta cercando una via di mezzo tra i populisti di destra e la sinistra, dove anche i partiti ex centristi vengono messi da parte dall’ala destra di Weber, che sostiene di essere il centro. Quando la destra moderata, liberale-conservatrice, cerca di definirsi come centro, segue automaticamente una linea di negoziazione verso destra, verso l’estrema destra. In questa prospettiva, il capo del governo populista di destra italiano, Georgia Meloni, svolge un ruolo chiave non solo in Italia ma anche nell’UE. È anche apprezzata dall’amministrazione Trump, che non desidera altro che rendere mainstream il populismo di destra conflittuale in Europa. [1]
L’erosione della democrazia dopo il 2008 dal suo status di bassa intensità verso regimi illiberali, autoritari e paternalistici è stata a lungo descritta come una morte strisciante, anche durante il primo mandato di Trump (Levitsky & Ziblatt 2018). Dopo sei mesi del secondo mandato di Trump, si deve parlare di un declino negli Stati Uniti che assomiglia a una frana. Nessuno parla più di morte strisciante. È questa la situazione che l’Europa deve finalmente affrontare, in modo autocritico ma con fiducia, senza borbottare sottovoce. E chiedersi quanto sia vicina a uno sviluppo americano.
Il problema nichilista: l’illimitato, l’immoderato, l’insensato, la senza-valore
Dopo l’abbandono del regime di produzione fordista, basato sulla produzione industriale con studi sui tempi, lavoro a cottimo e catene di montaggio come metodi, e investimenti in strutture fisse (mattoni e cemento) che duravano decenni e utilizzavano il petrolio come combustibile, è emersa una mentalità monetaria. La redditizia creazione di valore del futuro non risiedeva nella produzione di beni industriali, ma nel commercio di servizi finanziari. Il valore aggiunto risiedeva nel denaro stesso, che era sia il nuovo input che il prodotto finito. Con questa visione, crebbe la resistenza al controllo dei governi nazionali sul commercio delle valute e altri servizi finanziari. Crescevano le richieste di libero scambio transfrontaliero per i servizi finanziari. Durante gli anni ’90, i mercati finanziari furono liberati dai loro legami nazionali, ma questa liberazione era già iniziata negli anni ’80.
La monetizzazione dell’economia è cresciuta in modo esponenziale, poiché il motore della crescita economica si è spostato dalle immobilizzazioni ai portafogli monetari. Il profitto risiedeva nell’investimento nel denaro e nel commercio con il denaro. Il parametro che determinava i prezzi nel commercio delle materie prime, il denaro stesso, è diventato oggetto di determinazione dei prezzi e ha quindi acquisito un valore volatile. La monetizzazione dell’era neoliberista ha trasformato sempre più i valori in prezzi, rendendoli relativi, negoziabili e soggetti a speculazione. La pietra angolare del vecchio ordine, il prezzo dell’oro, è scomparsa in un mare di valori fluttuanti. Nel mercato senza confini, anche i valori che erano alla base della democrazia sono diventati negoziabili. Non solo i valori materiali, ma anche quelli immateriali e i principi etici sono stati trascinati nella tendenza nichilista secondo cui tutto ha un prezzo negoziabile. I valori assoluti e inestimabili sono diventati preziosi e negoziabili. I diritti umani non erano così assoluti come si diceva. Questo non valeva solo per gli Stati Uniti. I governi europei e l’UE pagano tangenti a governanti autoritari senza scrupoli a sud del Mediterraneo affinché i loro rappresentanti sostengano la nichilizzazione del canone di valori europeo. Il diritto di asilo ha un prezzo e non è più assoluto. I valori diventano illimitati, eccessivi, insensati e privi di valore (Stråth e Trüper 2025).
Donald Trump è l’illustrazione perfetta di questo sviluppo, l’uomo dei tecnocrati oligarchici per la creazione di nuovi valori. Niente rappresenta meglio questa creazione di valori intorno all’illimitato, all’immoderato e all’insensato, che finisce nel privo di valore, dell’immagine AI di Trump di se stesso come papa. Nel suo narcisismo senza pari, egli crede forse nell’immagine come una possibile realtà, proprio come crede in se stesso come vincitore del Premio Nobel per la Pace, che di per sé è una forma di nichilismo in cui si crede che tutto possa essere comprato. La digitalizzazione del commercio dei valori ha accelerato questo sviluppo. I social media sviluppano una dinamica che si rafforza a vicenda tra la creazione costante di nuovi valori e il consumo di valori (Stråth e Trüper 2025).
Un aspetto importante del nichilismo è che le regole e i codici culturali della sfera pubblica e della rappresentanza del potere politico si stanno dissolvendo. Il pubblico diventa privato e il privato diventa pubblico. In un articolo, lo storico Christopher Clark racconta una conferenza stampa televisiva alla Casa Bianca nel febbraio 2025, dove il First Buddy Elon Musk doveva riferire sul nuovo DOGE, Dipartimento per l’Efficienza Governativa. Clark provò orrore quando vide e sentì Musk parlare in modo incoerente e senza prove di come lui e il suo team avessero scoperto frodi su larga scala e corruzione senza fondo. Il presidente Trump sedeva alla sua scrivania nello Studio Ovale in un abito scuro. Musk era in piedi in jeans e soprabito con un cappellino MAGA in testa, che si toglieva solo per asciugarsi il sudore dalla fronte. I suoi movimenti erano goffi e parlava senza guardare negli occhi i giornalisti accovacciati davanti a lui. Forse era sotto l’effetto della ketamina. Aveva portato con sé suo figlio di quattro anni, di nome X Æ A ‒Xii. Mentre suo padre parlava, il figlio si metteva le dita nel naso e, con evidente disappunto del presidente, si spalmava il muco sull’angolo della venerabile scrivania Resolute (Clark 2025). Nessuno degli attori sembrava in grado di comprendere la natura pubblica della conferenza stampa. Era pubblica quanto può esserlo un evento del genere in una sala che, per la maggior parte degli americani, rappresenta l’autorità della presidenza più di ogni altra cosa. L’informalità radicale emanata dai due uomini e dal bambino, come se si fossero incontrati in privato a casa, era oscena, scrive Clark.
L’esempio può essere estremo, ma rappresenta una tendenza: il crollo dell’ordine pubblico. Un altro esempio è la riunione della NATO all’Aia nel giugno 2025, dove gli inchini e le ossequiosità davanti a papà Donald, come lo chiamava il segretario generale, erano espressione di quella che deve essere descritta come una crisi storica di valore. In un momento di guerra con questioni esistenziali da discutere, 32 capi di Stato e di governo si sono riuniti per un incontro il cui obiettivo principale era quello di mantenere Trump di buon umore. Con questo obiettivo in mente, la riunione doveva essere breve, solo un paio d’ore, in modo che l’attenzione di Trump non venisse meno. Tutti si sono congratulati quando l’obiettivo è stato raggiunto grazie alla mancanza di argomenti sostanziali da discutere. È stata tutta una cerimonia di corte di servilismo strisciante, con 31 leader mondiali che danzavano attorno al vitello d’oro, il leader numero 1. Il Segretario Generale era visibilmente soddisfatto del suo ruolo di capo giullare di corte. L’unica questione sul tavolo era il cinque per cento del PIL per la difesa, ma non era una questione da discutere, bensì un diktat, un bizzarro numero mistico tirato fuori dal nulla da Trump, che è stato accettato prima della riunione senza alcuna discussione sostanziale. È così che i leader europei vogliono garantire la sicurezza dell’Europa? Se no, perché lo fanno? Un incontro in cui il volubile Trump è rimasto calmo viene proclamato come una conferma della serietà dell’impegno degli Stati Uniti nei confronti della NATO. Davvero? Perché non c’era nessun adulto nella stanza? Spina dorsale? Fiducia in se stessi e rispetto di sé? Qualità di leadership? L’evento è stato una soap opera, in cui il pubblico non era interessato alla discussione di questioni serie, ma ai codici cerimoniali di corte e all’interpretazione dei segni, e in cui i social media hanno poi discusso appassionatamente se un sorriso fosse in realtà un ghigno.
La fede nelle possibilità illimitate del mercato, rafforzata durante gli anni di bonanza degli anni ’90, era legata a una fede altrettanto forte nelle possibilità del presente quando, in connessione con la liberalizzazione dei mercati finanziari, il controllo sui prestiti è stato privatizzato a favore degli emittenti di carte di credito e altre fonti finanziarie che fornivano credito per il consumo immediato. I lunghi orizzonti del futuro dell’era della pianificazione, quando la ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale prese il via e gli stati sociali si espansero, scomparvero in una nebbia lontana, e l’attenzione fu attirata da un presente frenetico in cui era importante consumare finché durava la festa. Si supponeva che sarebbe durata a lungo, ma il presente era ancora frenetico a causa della frenesia. Il regime temporale moderno che circondava la distinzione tra passato, presente e futuro, che teneva insieme il sistema di valori, si dissolse e si trasformò in un presentismo senza limiti (Hartog 2003; Stråth 2024).
Il potere interpretativo neoliberista e la monetizzazione, la liberalizzazione dei mercati finanziari, combinati con il potere digitale dei social media, hanno spinto lo sviluppo verso l’illimitato, l’eccessivo, l’insensato, per finire con la senza-valore in un presente che era diventato permanente. Un’espressione tipica dell’immoderato e dell’insensato è stata quando il banchiere tedesco Josef Ackermann ha affermato che un rendimento annuo del 25% era uno standard futuro per gli investimenti di capitale e il trading di denaro. Ha portato avanti il suo obiettivo come un ostensorio, proclamando instancabilmente che era realistico. L’obiettivo era un dogma. La conoscenza su Internet era illimitata. Gli algoritmi nelle mani degli operatori finanziari hanno creato valori di proporzioni finora inimmaginabili e hanno portato il gioco verso l’abisso, dove tutto è stato distrutto nel crollo del 2008. Democrazia e nichilismo non vanno d’accordo. La democrazia si basa sui valori.
Il potere degli algoritmi
I social media sono diventati un eccellente amplificatore di questo presentismo dell’eccesso, dove le comunicazioni sono diventate più brevi, più veloci e più univoche. Con l’aiuto degli algoritmi, il risultato è stato un linguaggio corrotto, dove l’ostilità e le emozioni hanno cambiato il dibattito pubblico e il discorso politico in modo devastante con semplificazioni e abbreviazioni di questioni complesse. La durezza e le emozioni non erano certo una novità nel dibattito pubblico, ma il ritmo e la diffusione erano nuovi e rendevano tutto più compresso. I social media sono il luogo in cui affondano le radici dell’infantilizzazione e della banalizzazione della politica, con ogni politico e ogni personaggio pubblico che si rispetti che si sente chiamato a esprimere un’opinione su tutto, dalle questioni grandi a quelle piccole, per dimostrare la propria presenza. Il linguaggio si impoverisce quando le emozioni e i pensieri intellettuali vengono espressi con le emoji.
Giuliano da Empoli ha spiegato in un breve saggio con un’analogia storica non solo cosa c’è in gioco, ma anche la mancanza di consapevolezza dell’offensiva degli oligarchi della tecnologia. Negli ultimi trent’anni, i leader politici delle democrazie occidentali si sono comportati come gli Aztechi di fronte alle invenzioni tecnologiche dei conquistadores, scrive da Empoli. Di fronte al fragore e ai lampi di Internet, dei social network e dell’intelligenza artificiale, si sono sottomessi nella speranza che un po’ di polvere magica cadesse su di loro. La loro docilità non è una soluzione per garantire la sopravvivenza della democrazia. Dopo aver finto di rispettare le regole della democrazia fintanto che erano in una posizione di inferiorità, gli oligarchi tecnologici conquistatori hanno gradualmente imposto il loro impero agli ignari Aztechi in forma moderna (da Empoli 2025: 12-13). In Europa, i governi esistono ancora come presunto contrappeso al potere delle piattaforme tecnologiche, ma con vaghe ambizioni di regolamentarlo. Negli Stati Uniti, la situazione sembra essere quella di una fusione con il potere governativo. La democrazia europea è il loro prossimo obiettivo.
Nel suo stile aforistico, da Empoli racconta le impressioni raccolte durante gli incontri in tutto il mondo come consulente di importanti politici italiani e descrive quanto fosse difficile per i politici comprendere e accettare le implicazioni della rivoluzione digitale.
Ma c’erano delle eccezioni. Da Empoli racconta, tra le altre cose, di Henry Kissinger a una conferenza nel 2015, dove Kissinger aveva intenzione di saltare la sessione sull’intelligenza artificiale, di cui non sapeva nulla. Ma, con precisione tedesca, si presentò comunque. E lì fu colpito da un fulmine: il fondatore di DeepMind stava presentando un software che avrebbe battuto il campione del mondo di Go. Kissinger capì immediatamente che la posta in gioco era molto più alta della digitalizzazione di un gioco da tavolo. E contrariamente a quanto aveva pensato, questo lo riguardava direttamente, nella sua veste di “storico e statista part-time”. Per la prima volta, ha osservato Kissinger, la conoscenza umana sta perdendo il suo carattere personale, gli individui vengono trasformati in dati e i dati stanno diventando dominanti. L’IA non è solo un semplice acceleratore di potere come la politica, ma una nuova forma di potere che differisce da tutte le macchine che gli esseri umani hanno inventato finora. Se l’automazione riguardava i mezzi, l’IA riguarda i fini. Essa stabilisce i propri obiettivi e sviluppa abilità che si pensava fossero riservate agli esseri umani. Prende decisioni strategiche sul futuro.
Mentre i suoi colleghi più giovani e i sostenitori della democrazia o gli ottimisti aziendali di Davos, i benevoli uomini di Davos, vedevano ancora solo una sfida tecnica, Kissinger capì che l’IA è una sfida politica. Tra gli statisti della generazione di Kissinger che avevano vissuto la guerra in gioventù, nessuno cadde nella trappola di vedere il potere come una competizione tra tecnocrati armati di presentazioni PowerPoint, riassume da Empoli le sue impressioni dagli incontri (da Empoli 2025: 126-127).
Il dilemma che ha caratterizzato la politica del XX secolo era il rapporto tra Stato e mercato: quanto delle nostre vite e delle funzioni della società dovrebbe essere controllato dallo Stato e quanto dovrebbe essere lasciato al mercato e alla società civile? Partendo da questo presupposto, da Empoli sostiene che la linea di demarcazione decisiva nel XXI secolo sarà quella tra esseri umani e macchine. In che misura le nostre vite dovrebbero essere soggette a potenti sistemi digitali e a quali condizioni? In definitiva, gli individui e le società devono decidere quali aspetti della vita debbano essere riservati all’intelligenza umana e quali debbano essere affidati all’IA o alla collaborazione tra esseri umani e IA. E ogni volta che sceglieranno di dare la priorità agli esseri umani, laddove l’IA avrebbe potuto garantire risultati più efficienti, ci sarà un prezzo da pagare (da Empoli 2025: 131). E viceversa, si potrebbe aggiungere.
Quindi, quali individui dovrebbero determinare il rapporto tra IA e intelligenza umana? Al momento, non c’è dubbio che siano gli oligarchi della tecnologia a considerare questa scelta come un loro compito. Se guardiamo al vicepresidente Vance come rappresentante della politica e consideriamo la sua dichiarazione alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco del febbraio 2025 (Stråth 2025), non c’è dubbio che, in ogni caso, i principali rappresentanti della politica americana siano d’accordo. Da Empoli contrappone la visione di Kissinger sull’IA, basata su una profonda formazione storica, all’ignoranza di Mark Zuckerberg. “È fantastico essere di nuovo a Pechino”, scrive il CEO di Facebook su una foto che lo ritrae in pantaloncini da jogging in Piazza Tienanmen, dove nel giugno 1989 migliaia di studenti furono massacrati dai militari (da Empoli 2025: 126).
La conclusione è ovvia. È di fondamentale importanza che i parlamenti e i governi assumano il controllo e regolino l’IA, e lo facciano in modo deciso e con grande chiarezza. I leader europei devono quindi prendere posizione contro le politiche rappresentate dal vicepresidente degli Stati Uniti. Non si tratta solo di regole relative all’IA, ma anche di interazione su Internet e creazione di piattaforme europee, cloud di archiviazione dati, sistemi di navigazione (la cui base esiste con Galileo), ecc. Si tratta anche di rendersi conto che il tempo è essenziale. Infine, si tratta della determinazione a non acquistare la libertà dai dazi statunitensi sulle merci rinunciando alla regolamentazione degli algoritmi nel commercio dei servizi.
E ora, Europa?
Nella situazione qui descritta, è il momento di allinearsi all’argomentazione di Etienne Balibar a favore di un’Europa sociale come risposta alla situazione (Balibar 2025). Il compito è quello di cercare le condizioni storiche per la proposta di Balibar.
Durante gli anni ’70, il progetto di integrazione europea era difficile da attuare. La politica agricola era sbagliata e l’unione doganale era insufficiente nella ricerca del posto dell’Europa nell’ordine mondiale. La crisi seguita al crollo del dollaro gettò un’ombra sul progetto. Il presidente francese Valéry Giscard d’Estaing e il cancelliere della Germania Ovest Helmut Schmidt lavorarono a una moneta europea che sostituisse il dollaro. In precedenza, Edward Heath, primo ministro del Regno Unito, membro della CEE dal 1973, e il cancelliere della Germania Ovest Willy Brandt avevano delineato un’unione monetaria tra la moneta della CEE e la sterlina, un piano più avanzato di quello di Giscard d’Estaing e Schmidt. Nel 1974, Heath fu costretto a dimettersi da Margaret Thatcher, che aveva idee completamente diverse, e Willy Brandt si dimise dopo che nella sua cancelleria fu scoperta una spia della Germania dell’Est (Stråth 2023: 179-180). Il momento kairos europeo in risposta al crollo del dollaro passò, ma i loro successori, d’Estaing e Schmidt, continuarono a lavorare in una direzione più tecnocratica. Nel novembre 1975 convocarono i leader di Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Italia a una riunione a Rambouillet, nei pressi di Parigi. Questo fu il presupposto per la nascita del G7 l’anno successivo, quando si aggiunse il Canada. Giscard d’Estaing e Schmidt volevano soprattutto ottenere il benestare degli Stati Uniti per una cooperazione monetaria europea più indipendente che sostituisse il dollaro in declino. Kissinger era fermamente contrario a tali piani, ma la riunione trovò una soluzione al collasso imminente. La questione valutaria fu accantonata e si raggiunse un accordo su un fronte unito dei paesi industrializzati contro le richieste NOEI del Terzo Mondo, il G7 contro il G77 (Stråth 2023: 109-115).
La cooperazione monetaria europea finì per ruotare attorno all’ecu e al serpente monetario all’ombra di un dollaro che si stava riprendendo senza un sistema aureo. Ma durante il periodo buio degli anni ’70 in Europa, ci fu un flusso costante di richieste per un’Europa più unita. Quel flusso si spostò dalle valute alla rappresentanza. Nel 1979, i cittadini dei nove Stati membri elessero per la prima volta i loro rappresentanti al Parlamento europeo, che in precedenza era un’assemblea di delegati nominati dai governi.
“Il dollaro è la nostra moneta, ma ora è un vostro problema”, aveva detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti agli europei quando gli Stati Uniti abbandonarono il gold standard. Il dollaro fluttuava liberamente rispetto alle altre valute ma, in mancanza di alternative, rimaneva il metro di misura del valore anche senza il sostegno dell’oro. Tutte le altre valute dovevano adeguarsi. Il problema era che più il dollaro si indeboliva, più l’inflazione aumentava. Nel 1979, la Federal Reserve tirò il freno di emergenza con una politica di inasprimento insolita che fece salire alle stelle i tassi di interesse, abbassò i salari reali e aumentò la disoccupazione. Fu l’allontanamento dell’amministrazione Carter dalle idee keynesiane. Per evitare la fuga di capitali oltreoceano, l’Europa occidentale entrò in una guerra dei tassi d’interesse con gli Stati Uniti, che alla fine dovette abbandonare. Il presidente Reagan continuò sulla stessa strada con un dollaro più forte, libero da vincoli, e un rapido smantellamento del sistema di Bretton Woods, che in Europa aveva costituito il quadro di riferimento per le economie miste keynesiane. Nel nuovo ordine, il dollaro continuò a regnare sovrano senza alcuna garanzia se non la fiducia in esso per mancanza di alternative, e gli europei si adattarono. Lo smantellamento di Bretton Woods fu accompagnato da una celebrazione apologetica della teoria del libero scambio economico per quanto riguarda beni, capitali e servizi. La deregolamentazione, la libera circolazione dei capitali, la privatizzazione, i tagli alle imposte sulle società, il ridimensionamento dell’apparato statale (“big government”) e dello stato sociale (che negli Stati Uniti non ha mai avuto la stessa dimensione che in Europa, nonostante il programma Great Society di Lyndon Johnson) divennero gli strumenti economici dell’era Reagan (Wilenz 2008; Arrighi 2010). L’Europa seguì l’esempio. Il presidente francese François Mitterrand e il ministro delle Finanze Jacques Delors fecero un ultimo tentativo keynesiano per stimolare la domanda nel 1981, come abbiamo visto, ma gli attacchi al franco e la fuga di valuta che ne seguì li costrinsero a gettare la spugna due anni dopo.
In qualità di ministro delle Finanze, Delors fu costretto ad attuare una politica di austerità fiscale, che applicò in modo così coerente che sia il primo ministro britannico Margaret Thatcher che il cancelliere della Germania Ovest Helmut Kohl, entrambi fedeli seguaci di Reagan, lo considerarono un nuovo convertito alla teoria neoliberista. Quando Mitterrand, per ragioni più personali, non volle nominare Delors presidente della Commissione nel 1985, essi intervennero e lo convinsero. Delors era la loro garanzia per un’Europa neoliberista.
Si sbagliavano di grosso. Ben presto sarebbe diventato evidente che la politica di austerità francese non era una questione di convinzione, ma piuttosto la consapevolezza che l’economia mista keynesiana non funzionava in un solo paese. Ma forse avrebbe funzionato in un contesto europeo, pensò Delors. Il suo piano era quello di sviluppare un’alternativa agli Stati Uniti, che avevano unilateralmente posto fine a Bretton Woods e, con un dollaro fluttuante, navigavano liberamente, alternando un impero produttivo a un impero consumistico. Delors osservò che gli Stati Uniti mantenevano i loro privilegi legati al dollaro, ma avevano rinunciato alle responsabilità transatlantiche che derivavano dalla posizione privilegiata e prioritaria del dollaro. Già come ministro delle finanze aveva criticato la situazione: «Imaginez que la France puisse financer son déficit commercial en créant des francs acceptés par tous», immaginate che la Francia possa finanziare il suo deficit commerciale creando un franco accettato da tutti (Bitumi 2017:7). Si era brutalmente reso conto che non era possibile. Ma forse con l’Europa?
In un articolo ben documentato, Alessandra Bitumi (2017) ha esaminato come Jacques Delors, che ha ricevuto la sua formazione politica nel movimento operaio cattolico, abbia iniziato a lavorare su una narrativa e una politica per un’Europa sociale in contrapposizione agli Stati Uniti neoliberisti del dollaro.
Al suo fianco, come vicepresidente della nuova Commissione nel 1985, Delors aveva Lord Cockfield, che era stato ministro delle Finanze e del Commercio nel governo di Margaret Thatcher e che, dal 1983, era stato sollevato dalle responsabilità dipartimentali per agire come il think tank individuale di Thatcher. Quando la Thatcher nominò Lord Cockfield commissario e vicepresidente nel 1985, lo fece per rafforzare quello che lei considerava il neoliberista Delors. La Thatcher si sbagliava anche su Lord Cockfield, che divenne l’artefice del mercato unico con le sue quattro libertà per beni, capitali, servizi e persone, elemento centrale dell’Atto unico europeo adottato dalla CE nel febbraio 1986, che, come previsto, portò al Trattato di Maastricht nel 1992. Nel 1985 Lord Cockfield aveva elencato in una relazione 300 misure necessarie per attuare il mercato unico. Il mercato unico aveva una dimensione sociale, un’Europa sociale di mercato con idee tratte dalla dottrina sociale cattolica e dalla teoria del mercato sociale della Germania occidentale.
Il contesto era quello della narrativa neoliberista, che aveva ancora Friedrich Hayek come punto di riferimento principale. La definizione neoliberista di libertà (di mercato) di Hayek aveva poco a che vedere con il laissez-faire. Hayek era il filosofo di casa della Thatcher, ma erano più le sue idee politiche sul concetto di libertà ad attrarla che le sue idee economiche, che lei comprendeva meno. Secondo Hayek, le libertà di mercato erano basate su regole, e su questo punto Delors e Lord Cockfield riuscirono a trovare un punto d’incontro ed evitare di essere percepiti come artefici di un controprogetto. La dimensione sociale sarebbe stata espressa nella formulazione delle regole. Allo stesso tempo, negli Stati Uniti iniziò l’era Reagan con una svolta verso il laissez-faire con la deregolamentazione, una transizione al capitalismo finanziario con l’abolizione delle norme sui movimenti di capitale, la privatizzazione dei servizi pubblici, i tagli fiscali per le imprese e i tagli alla politica sociale. Le promesse di disciplina di bilancio andavano di pari passo con il rapido aumento del deficit di bilancio e del debito pubblico. Le contraddizioni tra la pratica e la retorica di quella che veniva chiamata Reaganomics erano evidenti a chiunque volesse vederle e creavano un contrasto con l’Europa che Delors voleva costruire. Non c’è nulla che suggerisca che la Thatcher abbia colto questo contrasto. Contrariamente alle sue aspettative, Delors, assistito da Cockfield, non sarebbe stato l’uomo che avrebbe trasformato l’europeismo in thatcherismo. Non è chiaro quando la Thatcher si sia resa conto del suo errore di valutazione, ma Delors non fece nulla per nascondere il suo piano. Nei suoi discorsi e scritti, Delors trasmise la sua visione politica ed economica dell’Europa in contrasto con il modello anglo-americano di una società atomizzata e privatizzata, governata dall’esigenza di separazione tra Stato e mercato sotto la supremazia del mercato, incentrata sull’individuo e ossessionata dall’autoreferenzialità. La differenza che Delors vedeva tra Europa e Stati Uniti riguardava le diverse concettualizzazioni dei legami tra gli individui in una comunità di valori e norme (Bitumi 2017:10). Queste differenze portavano a diverse interpretazioni del concetto di libertà, del ruolo dello Stato e dell’importanza del mercato. L’ideale normativo che Delors aveva in mente era quello di rendere il dinamismo economico compatibile con la giustizia sociale. Un tale ordine si sarebbe consolidato in Europa e poi diffuso in tutto il mondo, in contrasto con un ordine mondiale americano che assomigliava a una volpe in un pollaio. Con questi piani, Delors si considerava un ingegnere sociale (Bitumi 2017: 11). Un’Europa più integrata avrebbe raggiunto gli Stati Uniti in termini di innovazione tecnologica e avrebbe così risposto a quella che Servan-Schreiber aveva definito vent’anni prima la sfida americana (Servan-Schreiber 1967). L’Europa sociale di Delors si basava su principi etici che motivavano misure di sostegno finanziario volte a colmare il divario tra il ricco centro dell’Europa e la sua periferia più povera e a risolvere il problema della disoccupazione di lunga durata.
Delors voleva che i diritti sociali e gli standard del mercato del lavoro facessero parte delle regole del mercato interno, un’europeizzazione delle regole attraverso l’armonizzazione. Su questo punto, c’era un netto scontro con la Thatcher, che si opponeva a qualsiasi rinuncia alla sovranità nazionale in ambito sociale. Nel 1988-1989, il conflitto tra la visione neoliberista e quella sociale di un’Europa anglosassone e di un’Europa “carolingia” raggiunse il suo apice. Quando divenne chiaro che la Thatcher non avrebbe rinnovato la nomina di Lord Cockfield a Commissario, Delors tenne un discorso a Brighton nel settembre 1988 su invito dei sindacati britannici, in cui pose la dimensione sociale al centro della nuova Europa. Delors sfidò la Thatcher nel suo stesso paese e respinse i suoi timori di un socialismo introdotto dalla porta di servizio. La Thatcher rispose due settimane dopo dal podio del Collège d’Europe a Bruges, che era essenzialmente il territorio di Delors. Si concentrò sui piani per un super Stato europeo sovranazionale, che era un colpo basso, poiché nessuno aveva sostenuto una cosa del genere. Prese le distanze da un’Europa socialista e corporativista, che non era nemmeno all’ordine del giorno. Il Wall Street Journal commentò: “L’America deve capire questo dibattito. Una sconfitta della visione della signora Thatcher sarebbe costosa per gli Stati Uniti. Dopo tutto, ci sono alcuni americani sepolti accanto ai soldati britannici in tutta Europa» (Bitumi 2017:14).
Il Trattato di Maastricht del 1992 sull’Unione Europea, frutto degli sforzi di Delors, fu un risultato significativo che approfondì l’integrazione europea. Ma Delors non era del tutto soddisfatto. La dimensione sociale della sua Europa fu trasformata a Maastricht dall’opposizione della Thatcher in un protocollo dell’accordo, ma nemmeno su questo gli undici Stati membri e il Regno Unito riuscirono a trovare un accordo senza che il Regno Unito avesse una riserva speciale sul protocollo. L’idea di armonizzare gli standard sociali aleggiava ancora sul dibattito su come l’Unione dovesse essere configurata nella pratica. Ma quando Delors lasciò la Commissione nel 1996, tutti i dodici governi membri concordarono su una clausola congiunta che confermava l’indebolimento della dimensione sociale. In linea con lo spirito neoliberista dell’epoca, l’accordo fu incorporato nel Trattato di Amsterdam del 1997, che respingeva l’idea di armonizzazione attraverso un nuovo linguaggio incentrato su concetti quali metodi di coordinamento aperti, benchmarking e migliori pratiche, aprendo la strada alla concorrenza reciproca tra gli Stati membri e alla pressione al ribasso sugli standard sociali. È stato proprio questo sviluppo che Mario Draghi ha criticato nella sua relazione sulla competitività dell’UE nel 2024 (UE 2024). Egli analizza come l’UE possa subire una trasformazione strutturale dalla concorrenza interna nel mercato interno a un raggruppamento interno attorno a concetti quali l’autonomia strategica, la competitività sostenibile e la prosperità sostenibile per una maggiore competitività esterna. Con un’enfasi esplicita sulla dimensione sociale, è facile trovare un collegamento con gli sforzi di Delors per un’Europa sociale. L’asse Delors-Draghi sarebbe un ottimo punto di partenza per una risposta europea alla le défi américain 2.0 nella forma di Trump.
Sulla questione della mancanza di alternative, del coraggio e della visione di un’Europa sociale
La politica era dettata dal mercato, non c’erano alternative, secondo un mantra neoliberista da Thatcher a Merkel. La mancanza di alternative è al centro della democrazia a bassa intensità che ha portato a una crisi della democrazia liberale in quanto tale, come la conosciamo dalle economie miste keynesiane degli Stati sociali dell’Europa occidentale durante un paio di decenni a partire dagli anni ’50. Quindi, in una parte limitata del mondo. Il declino è stato accompagnato da una ripresa delle forme di governo autocratiche e paternalistiche illiberali portate avanti dal populismo di destra. Molto non è chiaro su come sia avvenuto precisamente il declino e su come debba essere spiegato, ma alcuni fattori che hanno contribuito sembrano evidenti. Una delle ragioni principali è la convinzione, perché era/è una convinzione, che la politica sia soggetta al mercato. Questa convinzione, questa ideologia, è una sottomissione che rende impossibile una lotta democratica per alternative e scelte nel plasmare il futuro. La bassa intensità e il passaggio da una politica guidata da interessi e ideologie a una ricerca tecnocratica della massimizzazione dei voti ha reso possibile credere in una politica democratica senza alternative.
La democrazia richiede non solo alternative guidate dall’ideologia e dagli interessi, ma anche leadership. Non è sufficiente dire che la democrazia è il potere del popolo, nel senso che è il popolo a decidere. La democrazia consiste certamente nell’ascoltare il popolo, ma consiste anche nel guidarlo verso degli obiettivi attraverso visioni e piani per attuare tali visioni. La leadership consiste anche nel trovare compromessi tra obiettivi diversi, perché il popolo non è uno, ma molti con obiettivi diversi. Ascoltare, guidare, scendere a compromessi e governare sono gli ingredienti di una democrazia vivace. Anche i leader populisti ascoltano, ma per ottenere voti per obiettivi che loro stessi definiscono. I cartelli dei partiti che massimizzano i voti ascoltano, ma non hanno obiettivi chiari. Sono guidati da ciò che sentono piuttosto che da ciò che controllano. La consapevolezza di queste distinzioni è andata perduta sotto aspetti importanti. È importante ripristinarla.
Ci sono sempre più richieste di coraggio in politica. È stato sostenuto che viviamo in un’epoca post-eroica (Münkler 2007). Naturalmente, non si tratta del coraggio militare sul campo di battaglia in tempo di guerra, ma del coraggio intellettuale di assumersi la responsabilità di decisioni importanti e difficili, di sostenerle e di fare tutto il possibile per attuarle. La democrazia richiede leader con autorità intellettuale, immaginazione e carisma. E la capacità di assumersi la responsabilità delle sconfitte e di imparare da esse.
Si tratta di un argomento che richiede ulteriori approfondimenti, ma che è difficile da ignorare: con la mancanza di alternative come credo, un’intera generazione di politici ha perso il credo, l’ethos e l’habitus che hanno caratterizzato la politica democratica fino agli anni ’80. Sembra esserci una connessione con il crollo dell’ordine mondiale della Guerra Fredda e l’euforia scatenata da pensieri frivoli su un futuro privo di problemi. In quel momento, si affermò anche la narrativa neoliberista della mancanza di alternative sotto il diktat del mercato. Quando questa crollò nella bolla speculativa del 2008 e il motto della mancanza di alternative in politica sotto il mercato divenne “too big to fail” con giganteschi interventi statali, molti si sentirono traditi. È stato dopo il 2008 che il populismo di destra e il paternalismo autocratico illiberale hanno fatto la loro comparsa, prendendo di mira i “cosmopoliti” e i “globalisti” neoliberisti, ma la critica al progetto neoliberista era già iniziata negli Stati Uniti intorno al 2000, come abbiamo visto (Stråth 2025). La convinzione che non esistano alternative ha accompagnato questo sviluppo e ha permesso a imprenditori politici intraprendenti di dare a questa mancanza di alternative una forma autoritaria e nazionalista.
Questo sviluppo, che ora sembra sempre più chiaro, fino a poco tempo fa appariva molto più vago. Negli Stati Uniti si parlava della morte strisciante e insidiosa della democrazia (Levitsky e Ziblatt 2018). Non c’è un punto chiaro in cui resistere. La gente segue, con sentimenti spiacevoli in un paesaggio crepuscolare, senza sapere cosa fare fino a quando tutto non si ribalta ed è troppo tardi, quando il piano inclinato innesca la frana. È lì che si sono trovati gli Stati Uniti nel gennaio 2025. È proprio questo sviluppo che Habermas mette in guardia (Habermas 2025; cfr. Stråth 2025) e esorta i leader europei a opporsi e fermarlo prima che sia troppo tardi. Trump non ha motivazioni caritatevoli, solo i propri interessi, che definisce in modo cinico ed enigmatico. C’è un divario tra ciò che dice e ciò che fa. Ma sarebbe un grave errore vedere Trump come qualcosa di tipicamente americano che non può accadere in Europa. L’amministrazione Trump e gli oligarchi della tecnologia sono impegnati in qualcosa di molto grande, una ristrutturazione dell’ordine mondiale attraverso un’espansione sistematica e deliberata del potere esecutivo a scapito del potere parlamentare. Che i piani di ristrutturazione, che non sono necessariamente molto concreti o sostenuti all’unanimità dalla leadership, abbiano successo o finiscano in un’anarchia globale, l’Europa e le condizioni per la democrazia in Europa ne saranno fortemente influenzate.
In assenza di ricerche sistematiche, questa è un’ipotesi piuttosto che un’argomentazione: i politici che non offrono alternative sono diventati apostoli dell’impotenza. Il centro politico senza alternative è diventato il centro dell’impotenza, dove tutti sono ammassati ma non vogliono accorgersi di essere trascinati a destra, dove si svolge la politica creativa. Non si accorgono, o non vogliono accorgersi, che la creatività sta andando nella direzione sbagliata. È necessario un nuovo centro, con conflitti e compromessi di idee e interessi tra alternative socialdemocratiche, social-liberali e social-conservatrici. La questione della distribuzione deve essere nuovamente affrontata come il conflitto che rappresenta, con l’obiettivo di trovare compromessi. Il mito che il mercato risolva automaticamente e armoniosamente il conflitto per tutti deve essere respinto. Il conflitto sulla distribuzione deve poter tornare a farsi sentire, non solo a livello nazionale ma anche globale. Non è più possibile fingere che non esista. È necessario creare una nuova via di mezzo, che prenda le distanze dal neoliberismo che è crollato e non ha più nulla da offrire se non distruzione, senza alcuna riflessione su cosa succederà dopo la distruzione o su cosa esattamente debba essere distrutto e perché. Un nuovo terreno comune che prenda le distanze anche dal lavoro del nazionalismo sociale che ha la storia come futuro, dove i costruttori di destra chiudono un occhio su quanto facilmente il nazionalismo sociale si trasformi in nazionalsocialismo, chiudendo un occhio o desiderandolo.
La distinzione tra consumo e investimento è andata persa nella dottrina di bilancio che sopravvive dall’era Reagan. Secondo tale ideologia, i tagli fiscali per le fasce di reddito più elevate stimolano l’economia e rimettono in moto gli ingranaggi quando questi minacciano di fermarsi. La dottrina era la risposta degli economisti dell’offerta alla stimolazione della domanda keynesiana, che aveva un’ambizione di politica distributiva. La questione della distribuzione è presente anche nel reaganismo, ma non come un problema bensì come un bonus, non dall’alto verso il basso ma dal basso verso l’alto, come ha dimostrato in modo dettagliato Thomas Piketty (2014). Il reaganismo ha risolto e risolve il problema della distribuzione con la teoria del letame: pochi chicchi d’avena vengono lasciati ai passeri, i poveri. In una metafora più appetitosa, l’idea è chiamata trickle down. Keynes capì la differenza tra stimolare la domanda in un’economia in declino e stimolare l’inflazione se il metodo veniva utilizzato per risolvere problemi strutturali. Quando i discepoli di Keynes non riuscirono a capirlo durante la crisi strutturale degli anni ’70, si verificò il fenomeno della stagflazione, che fu una sorpresa. Anche i pensatori neoliberisti hanno perso di vista la distinzione tra ciclo economico e struttura quando sostengono i tagli fiscali. Ignorano la differenza tra consumo e investimento quando sottolineano la necessità di un bilancio equilibrato in tutte le situazioni. Se i tagli fiscali portano a deficit, si dice che sono temporanei. A lungo termine, i tagli fiscali si finanzieranno da soli, dicono. Queste questioni devono essere nuovamente discusse, mettendo in luce le contraddizioni fondamentali. È un prerequisito importante per una democrazia vivace che ciò avvenga.
È necessaria una nuova teoria economica per risolvere i principali problemi esistenziali che riguardano il clima e l’ambiente e la distribuzione globale delle risorse e del reddito del pianeta. Non si tratta di reinventare la ruota, ma di pensare in modo nuovo a questioni vecchie. L’economista Mariana Mazzucato (2021) vuole cambiare le basi economiche dell’attuale mancanza di azione politica e di governance in materia di economia. Il suo libro Mission Economy presenta in modo appassionato e convincente una nuova visione della politica e dell’economia che si lascia alle spalle la mancanza di alternative neoliberiste. Il suo caso di studio è il satellite spia russo Sputnik del 1957, che ha sconvolto gli Stati Uniti e ha portato al progetto Apollo dell’amministrazione Kennedy, basato sulla decisione di portare un uomo sulla luna entro dieci anni. Mazzucato descrive come l’amministrazione abbia assunto la guida del progetto, mobilitato e coordinato l’industria, gli istituti di ricerca e i media, discusso gli obiettivi intermedi senza un controllo dall’alto e coinvolto tutti nel lavoro verso l’obiettivo. Il punto era la leadership politica che ha creato il coinvolgimento dal basso. Ella dimostra che l’industria e l’economia non sono solo una questione di profitti per gli azionisti, ma che c’erano anche interessi pubblici con vari stakeholder, in contrapposizione agli azionisti. Far collaborare questi interessi faceva parte del coordinamento politico. Questo coordinamento richiede una visione a lungo termine che deve essere costantemente tenuta presente e aggiornata. Il modello di Mazzucato permea l’economia con visioni, organizzazione, ambizioni e interesse pubblico, qualità che sono scomparse nell’economia monetaria degli interessi di profitto a breve termine e della speculazione. Invece di fare di uno spazio di bilancio fisso immaginario il punto di partenza della politica, Mazzucato sostiene che si dovrebbe partire da una visione del futuro e dalla politica per attuare tale visione, e da lì creare lo spazio finanziario per l’obiettivo politico. Come nel caso del progetto Apollo. Il modello e il pensiero che lo sottende si collegano molto bene al lavoro di Delors per un’Europa sociale. La sfida posta dal libro di Mazzucato è perché i grandi progetti hanno così spesso un’origine e uno scopo militare. Perché sono così spesso legati a questioni esistenziali importanti relative alle armi? Anche un’Europa sociale e un pianeta con un clima adatto alla sopravvivenza sono questioni altamente esistenziali. Il libro di Mazzucato è scomparso troppo facilmente e troppo rapidamente durante la pandemia. Merita di essere preso molto sul serio attraverso un dibattito approfondito su come le sue idee possano essere realizzate. Con la diffusione delle idee del libro, anche proposte più radicali per l’economia del futuro potrebbero entrare nell’arena pubblica (Quilligan e Stråth 2025).
Il moralismo non è un buon principio per l’azione politica, ma durante l’era nichilista del mercato, senza alternative, si è dimenticato che senza valori etici e morali, senza norme, la politica basata sulle regole e la politica democratica non funzionano. Jacques Delors lo sapeva nel suo lavoro su un’Europa sociale. Ha osato delineare e sostenere una grande visione. Ha osato assumersi la responsabilità di una politica che correggesse e completasse un’Europa puramente guidata dal mercato. Voleva creare un’Europa che fosse più di un sistema à la carte in cui ognuno sceglieva gli aspetti che gli davano vantaggi, ma non voleva essere parte dei compromessi e dei sacrifici necessari per formare un’Europa comune. Per impedire lo sviluppo che il regime di Trump ha promosso, un ordine mondiale lontano da quello odierno e orientato verso qualcos’altro, che si tratti dell’anarchia globale o del trionfo degli algoritmi, è necessaria un’Europa diversa. Un’Europa diversa, i cui leader si assumano la responsabilità reciproca in quella che è una comunità europea di destino. Se i paesi del nord ritengono importante la difesa dalla minaccia proveniente dall’est, devono chiedersi cosa possa far sentire coinvolti membri come l’Italia, la Spagna e il Portogallo. Forse una politica comune in materia di rifugiati e immigrazione con responsabilità congiunta per ciò che è noto come Schengen sarebbe una possibilità. Ma una politica in materia di rifugiati e immigrazione basata su valori completamente diversi da quelli attualmente praticati. Ciò, a sua volta, richiede leader che osino pensare in modo visionario e si assumano la responsabilità delle loro idee. In questo contesto, Delors, con l’aiuto di Mario Draghi, potrebbe fungere da modello per la costruzione di un’Europa che si assuma la responsabilità globale e planetaria per sé stessa e per il mondo, in modo diverso da come hanno fatto le potenze europee sotto i concetti di colonialismo e imperialismo. In altre parole, l’Europa come contrappunto agli Stati Uniti di oggi. Un terzo articolo dal titolo “Un ordine mondiale in dissoluzione” svilupperà questa idea.
In definitiva, la questione del giorno è quella della leadership. In un momento in cui gli ideali autocratici e paternalistici sembrano caratterizzare lo stile di leadership, sarebbe importante avviare un dibattito sui valori e sulle norme basato su due problemi: la questione della convivenza dignitosa sul pianeta Terra e le possibilità e i rischi degli algoritmi, nonché, naturalmente, il potere su di essi. Ampliare il dibattito in questa direzione porta automaticamente a un collegamento con la questione esistenziale del clima e dell’ambiente. La domanda fondamentale è, ovviamente, se la democrazia possa essere salvata. Si tratta di cercare di vedere il mondo così com’è senza dimenticare la questione di come dovrebbe essere. Il punto di partenza deve essere la consapevolezza che la storia non è predeterminata, ma è creata dall’azione o dall’inazione umana. Il compito è quello di sviluppare nuove prospettive e un nuovo discorso sul futuro, lontano dalla mancanza di alternative e dai dettami del mercato. Il discorso crea il quadro di riferimento per l’azione. La leadership segue il discorso, ma allo stesso tempo lo crea e lo sviluppa.
Traduzione di DeepL e Bo Stråth dallo svedese dell’articolo Bo Stråth, “En världsordning i upplösning. Vad nu? 2. Den lågintensiva demokratin utan alternativ, nihilismen och algoritmerna.” Statsvetenskaplig Tidskrift Vol 128 Nr 3 settembre 2025.
Nota finale
[1] Meloni potrebbe rappresentare un nuovo stile politico che colma il divario tra il conservatorismo liberale moderato e il populismo di destra. Nonostante le sue origini nel movimento neofascista, non segue realmente il modello autoritario-paternalistico del populismo di destra, anche se ci sono segnali in questa direzione, come la ristrutturazione della RAI. Non forma un fronte unito con il leader della Lega Matteo Salvini, il cui partito populista di destra fa parte della base di governo, come dimostrano la sua posizione più moderata di Salvini sull’immigrazione e il suo allontanamento dal leader della Lega, favorevole a Putin, attraverso il suo sostegno all’Ucraina. Mantiene Salvini a distanza. La domanda è se stia effettivamente cercando di colmare un vuoto creatosi con il crollo del Partito Democratico Cristiano italiano negli anni ’90, un vuoto che anche Berlusconi ha cercato di colmare senza riuscirci davvero. Allo stesso modo, anche Meloni sta cercando di trovare un equilibrio tra la destra moderata e l’estrema destra in Europa. Questo esempio mostra quanto sia complessa la politica di destra. È chiaro che il baricentro politico si è spostato a destra, ma le implicazioni non sono così chiare.
A seguire:
“Un ordine mondiale in dissoluzione. E adesso? 3. Un’Europa basata sui valori in un’epoca nichilista. Verso un nomos per una società globale.” Dicembre 2025
Riferimenti:
Arrighi, Giovanni, 2010. “The World Economy and the Cold War, 1970-1990”, in Leffler, Melvyn P. & Westad, Odd A., (a cura di) The Cambridge History of the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, Vol 3: 49. Citato da Bitumi 2017:8.
Balibar, Etienne, 2025. “L’impossibile possibilità della federazione europea: ieri, oggi, domani.” Blog. https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/limpossibile-possibilita-della-federazione-europea/ Pubblicato il 08.12.2025
Bitumi, Alessandra, 2017. “Narrating Social Europe. The Search for Progress in the ‘Age of Delors’” (Raccontare l’Europa sociale. La ricerca del progresso nell’era di Delors). Notre Europe Policy Paper, 27 gennaio.
Clark, Christopher, 2025. “Ist Trump Faschist?” (Trump è fascista?). Süddeutsche Zeitung, 27 giugno.
Crouch, Colin, 2009. “Privatised Keynesism: An Unacknowledged Regime.”, The British Journal of Politics and International Relations 11(3), pp. 382-399.
Crozier, Michel J., Huntington, Samuel P. & Watanuki, Joji, 1975. The Crisis of Democracy Report on the Governability of Democracy to the Trilateral Commission. New York: New York University Press.
van Eeden, Pepijn, 2019. “Discover, Instrumentalize, Monopolize: Fidesz’s Three-step Blueprint for a Populist Take-over of Referendums,” East European Politics and Societies 33(3), p. 3.
Da Empoli, Giuliano, 2025. L’heure des prédateurs. Parigi: Gallimard.
Gustavsson, Rolf, 2010. Sveriges statsministrar under 100 år: Ingvar Carlsson. Stoccolma: Albert Bonniers.
Habermas, Jürgen, 2025. “Für Europa,” Süddeutsche Zeitung, 21 marzo 2025.
Hanson, Stephen E. & Kopstein, Jeffrey S., 2024. The Assault on the State. How the Global Attack on Modern Government Endangers Our Future. Cambridge: Polity Press.
Hartog, François, 2003. Des régimes d’historicité: Présentisme et expériences du temps. Parigi: Seuil.
Lang, Andrew, 2011. World Trade Law After Neoliberalism: Re-Imaging the Global Economic Order. Oxford: OUP
Levitsky, Steven & Ziblatt, Daniel, 2018. This is how democracies die. Penguin Books.
Lewis, Michael, 2018. The Fifth Risk: Undoing Democracy. WW Norton & Company.
Mair, Peter, 2013. Ruling the Void. The Hollowing of Western Democracy. Londra: Verso.
Marks, Susan, 2000. The Riddle of All Constitutions: International Law, Democracy, and the Critique of Ideology. Oxford: Oxford University Press.
Mazzucato, Mariana, 2021. Mission Economy. A Moonshot Guide to Changing Capitalism. Londra: Allen Lane.
Moyn, Samuel, 2010. The Last Utopia. Human Rights in History. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Moyn, Samuel, 2018. Not Enough: Human Rights in an Unequal World. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Münkler, Herfried, 2007. “Heroische und postheroische Gesellschaften,” Merkur n. 700, settembre.
Quilligan, James & Stråth, Bo, 2025. “The Value of Energy. Tre conversazioni between Bo Stråth and James Quilligan”. Blog https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/the-value-of-energy-conversations-with-james-quilligan Pubblicato il 04.01.2025.
Piketty, Thomas, 2014. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rodrik, Dani, 2000. “How Far Will International Economic Integration Go?” Journal of Economic Perspectives 14, pp. 177-186.
Servan-Schreiber, Jean-Jacques, 1967. Le défi américain. Parigi: Versilio.
Stråth, Bo, 2023. The Brandt Commission and the Multinationals. Planetary Perspectives. Londra: Routledge.
Stråth, Bo, 2024. “Where did the future go, and can it be reshaped?” Blog https://bostrath.com/planetary-perspectives/ordering-of-space-and-time/where-did-the-future-go/ Pubblicato il 17.09.2024.
Stråth, Bo, 2025. “Un ordine mondiale in dissoluzione. E adesso? 1. L’incontro degli imperi in Europa e la risposta dell’Europa”. Blog. https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/un-ordre-mondial-en-dissolution-et-maintenant/ Pubblicato il 06.07.2025
Stråth, Bo & Trüper, Henning, 2025. “Conceptualizing Capitalism. Conversations with Henning Trüper. Blog 4. Blog 4. The Zeitgeist of Empire and Nihilism in Historical Perspective. And Capitalism? https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/conceptualizing-capitalism/conceptualizing-capitalism-four-conversations-with-henning-truper/.
UE, 2024. Il rapporto Draghi. A e B. Bruxelles: Commissione europea.
Varoufakis, Yanis, 2011. Global Minotaur: America, Europe and the Future of Global Economy. Londra: Zed Books.
Wilentz, Sean, 2000. The Age of Reagan, 1974-2008. New York: Harper Collins.
Come citare:
Cit. Bo Stråth, “Un ordine mondiale in dissoluzione. E adesso? 2. Democrazia a bassa intensità senza alternative, nichilismo e algoritmi” Blog. https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/un-ordine-mondiale-in-dissoluzione-e-adesso-2/ Published 24.09.2025
Comments
Please submit you comments with the Contact Form or send an Email to bo.strath@gmail.com.